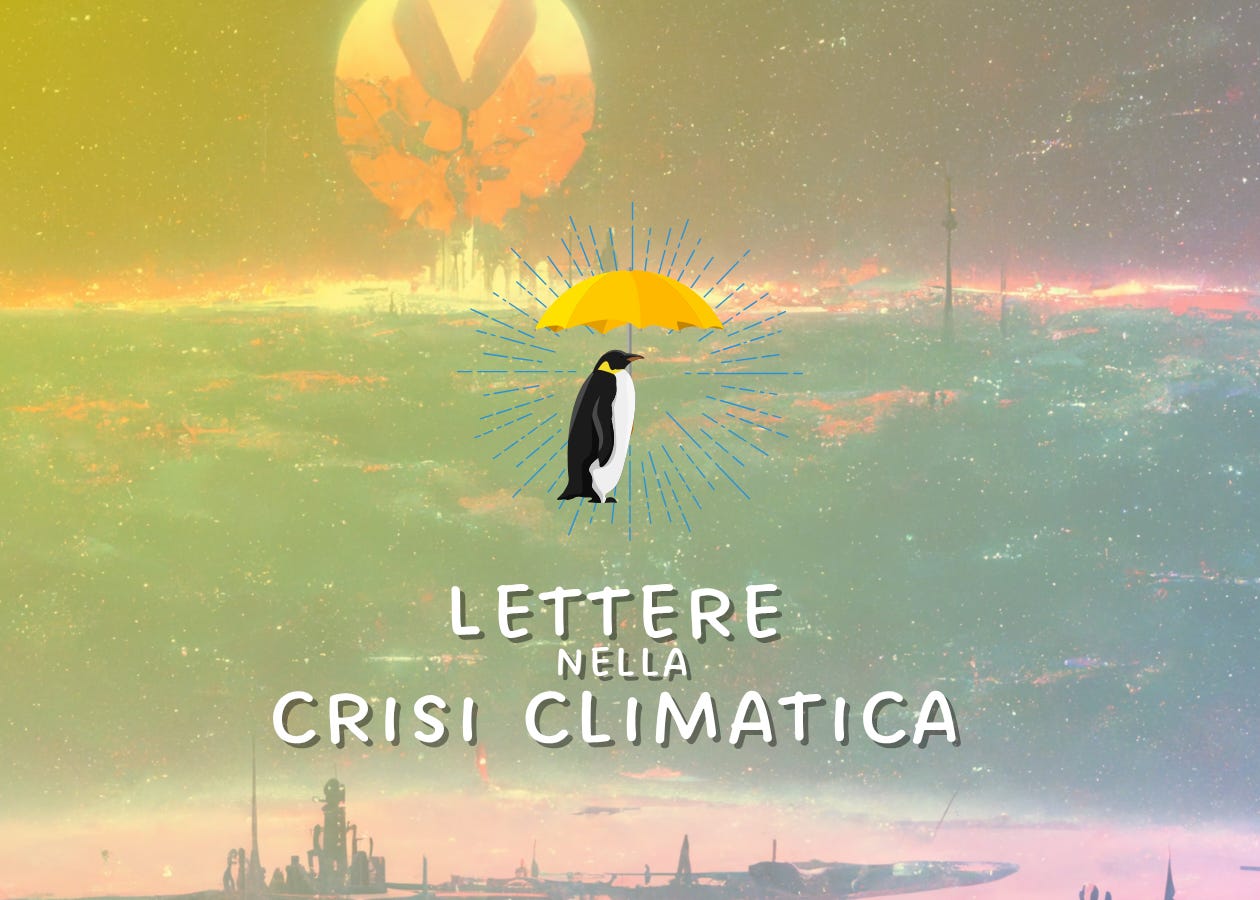Il dilemma del porcospino e le complessità dello stare insieme
Da Schopenhauer a Neon Genesis Evangelion, passando per Freud, una riflessione sullo stare insieme
Volendo dialogare con te sulla definizione della crisi climatica ho deciso di dedicare questa lettera al dilemma del porcospino di Schopenhauer, ripreso successivamente da Freud e addirittura da Neon Genesis Evangelion. Credo che riflettere sulla complessità dello “stare insieme” sia fondamentale per trovare una soluzione agli effetti del cambiamento climatico e, se sai che adoro parlare dello storytelling e della sua capacità di raccontare e cambiare il mondo, capirai quanto il collegamento all’opera di Hideaki Anno abbia rappresentato un motivo in più per scrivere questa lettera.
Cos’è il dilemma del porcospino?
Il dilemma del porcospino afferma che gli esseri umani desiderano avvicinarsi e collaborare ma, nonostante le loro intenzioni, più si avvicinano e più rischiano farsi male reciprocamente.
Il dilemma del porcospino è sostanzialmente una metafora, ideata da Arthur Schopenhauer, che illustra la difficoltà degli esseri umani nel mantenere un equilibrio nelle relazioni e come queste rischiano di oscillare tra passioni felici e passioni tristi. Successivamente Freud ha ripreso il dilemma del porcospino per descrivere la psicologia dei gruppi, mentre Hideaki Anno ha strutturato le relazioni e la psicologia dei personaggi di Neon Genesis Evangelion proprio ispirandosi ai porcospini di Schopenauer.
I porcospini di Schopenhauer
L’origine del dilemma del porcospino è attribuita a Schopenhauer e trova spazio in una parabola sui porcospini contenuta nel suo ultimo libro prima della morte, ossia “Parerga e Paralipomena” (1851, traducibile con “digressioni e omissioni):
“Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, cominciarono a pungersi a vicenda con gli aculei; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripeté quel malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.
Così il bisogno di società, che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l'uno verso l'altro; le loro molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili, però, li respingono di nuovo l'uno lontano dall'altro. La distanza media, che essi riescono finalmente a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone maniere.
A colui che non mantiene quella distanza, si dice in Inghilterra: keep your distance! - Con essa il bisogno del calore reciproco viene soddisfatto in modo incompleto, in compenso però non si soffre delle spine altrui. Colui, però, che possiede molto calore interno preferisce rinunciare alla società, per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli.”
(Arthur Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, Capitolo 31 “Similitudini, parabole e favole”, sez. 396, ed. Gli Adelphi - Tomo II, a cura di Mario Carpitella, p. 884)
Schopenhauer con i porcospini vuole mostrare il bisogno dell’essere umano di sentirsi intimamente e affettivamente connesso. Tuttavia lo stesso Schopenhauer, conosciuto per una concezione filosofica caratterizzata da un forte pessimismo, ritiene che le regole sociali e la stessa natura umana ci impediscono una reale connessione.
Senza addentrarci nel pensiero di Schopenhauer, ricordiamoci che è lo stessa persona famosa per l’aforisma “la vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia”. Insomma, detta così non è certamente la cosa più allegra che leggerai oggi però dietro la metafora del pendolo vi è il pensiero secondo cui la vita è sostanzialmente mossa da un desiderio “insaziabile”.
Il desiderio, nel momento in cui non è appagato, è una mancanza che produce “dolore” e che, una volta soddisfatto, si trasforma in noia. La felicità diventa quindi quel frangente, quel momento intermedio, in cui si passa dallo stato di “dolore” allo stato di “noia” con la conseguenza che una volta annoiato l’essere umano cercherà di soddisfare un nuovo desiderio, come in un movimento infinito.
Nel caso del teorema del porcospino, il movimento è dato dal desiderio di stare insieme per riscaldarsi ma una volta che si avvicinano troppo si fanno del male, per questo fanno avanti e indietro. Schopenhauer quindi critica la condizione umana affermando che le regole sociali, mettendoci in una posizione di comodo, ci permettono di stare insieme “alla giusta distanza”, impedendoci di entrare realmente in contatto con gli altri.
I porcospini di Schopenhauer suggeriscono che abbiamo un bisogno fondamentale di relazioni sociali dagli effetti positivi ma che il fallimento nel soddisfare questo bisogno ha spesso conseguenze devastanti. Ad esempio potrebbe provocare passioni tristi come solitudine, depressione, ansia o gelosia ma anche fenomeni di esclusione sociale.
Per rispondere a questa necessità l’umanità avrebbe progressivamente costruito delle barriere invisibili frutto di un lungo processo culturale per mantenere una “distanza ideale”, come nel caso delle “buone maniere” citate nella parabola.
Il teorema del porcospino, il legame tra Schopenhauer e Freud
Il dilemma del porcospino è stato ripreso da un Sigmund Freud, fondatore della psicoanalisi, per formulare le proprie riflessioni sulla psicologia dei gruppi, che ritiene coesi grazie a dei “legami libidinosi” ossia all'energia delle pulsioni.
Per Freud la psicoanalisi dimostrerebbe che ogni relazione tra due persone è affetta da una sorta di “sindrome del porcospino” perché contiene, accanto all’amore, dei sentimenti di avversione e ostilità che sfuggono alla percezione solo grazie alla rimozione. Comunque per Freud l’oscillazione dei porcospini di Schopenhauer non va intesa come un punto fisso di "comfort" ma va ricercata volta per volta.
In questo continuo assestamento entra in gioco “l’amor proprio” che reagisce alle minime divergenze di chi ci è vicino, sia nella coppia sia in gruppi più grandi. Anzi, le piccole differenze “pungono” più di quelle grandi perché sembrano una critica al nostro modo di essere e possono suscitare passioni tristi. Pensa che fa l’esempio delle ostilità tra popolazioni che vivono a nord e a sud di un Paese.
Quando si forma un gruppo però si accentua il sentimento di rimozione e chi ne fa parte tollera gli altri come se le differenze sparissero. La chiave di questo processo è la libido, intesa come pulsione comune verso “oggetto” comune (una figura di leadership, una causa o un ideale). Con l’idealizzazione di questo “oggetto”, le persone spostano le attenzioni dall’amor proprio all’oggetto condiviso col gruppo fino a identificarsi con esso. Queste “punture” però rimangono latenti e il dolore provocato tende ad essere diretto verso l’esterno (l’odio verso altri gruppi rafforza l’identità interna) o verso l’interno (quando vacilla l’idealizzazione comune riemergono e provocano fratture, scissioni o capri espiatori interni).
Il teorema del porcospino, secondo Freud, si presta ad essere utilizzato per descrivere la dinamica tra gruppi. Se lo prendiamo sul serio, ciò potrebbe significare che i gruppi devono condividere qualcosa e hanno bisogno di istituzionalizzare quei “distanziatori” utili ad evitare il “dolore delle punture”, attraverso ad esempio regole chiare di gestione del conflitto. Per questo sarebbe opportuno riconoscere e incanalare il dissenso per evitare di innescare dinamiche di conflitto.
Neon Genesis Evangelion e il dilemma del porcospino
Il dilemma del porcospino è stato ripreso in Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno dove, in un dialogo tra Misato e Ritsuko, si dice:
“Più ci avviciniamo, più ci feriamo profondamente”.
Ciò che rende unico Neon Genesis Evangelion non sono le epiche battaglie tra dei misteriosi nemici giganti chiamati “Angeli” e le unità Evangelion (gli enormi umanoidi artificiali conosciuti come EVA), bensì i numerosi riferimenti religioso (cabalistici, ebraici e biblici), la profonda caratterizzazione dei personaggi e il modo in cui vengono affrontate profonde questioni psicologiche e filosofiche.
La trama di Neon Genesis Evangelion
Se non conosci la trama di Neon Genesis Evangelion, ti posso dire che la storia si svolge quindici anni dopo un evento catastrofico noto come Second Impact, che ha portato a enormi cambiamenti climatici e a un lungo periodo di instabilità che ha ridotto la popolazione mondiale. Al centro della storia c’è il giovane quattordicenne e introverso Shinji Ikari che viene reclutato dal padre Gendo, comandante dell’agenzia speciale Nerv, per pilotare l’EVA-01 ed affrontare gli Angeli in qualità di Third Children. Per fare ciò Shinji si trasferisce a Neo Tokyo-3 dove però non va a vivere con il padre che lo aveva abbandonato dieci anni prima. Shinji va infatti a vivere con la sua nuova tutrice Misato Katsuragi e conosce le sue colleghe Rei Ayanami (First Children pilota dell'Eva-00) e Asuka Sōryū Langley (Second Children pilota dell'Eva-02).
Le relazioni tra i personaggi di Neon Genesis Evangelion
Il dilemma del porcospino sintetizza la dinamica delle relazioni tra i personaggi di Neon Genesis Evangelion e non è un caso che viene tirato in ballo nella conversazione tra Misato e Ritsuko.
Misato è una donna spontanea, affettuosa, confusionaria, con un forte amore per l’alcool e per i comportamenti poco educativi che si trova a fare da madre sia a Shinji che ad Asuka. Shinji è invece un ragazzo che lotta costantemente contro la depressione e l’ansia, d’altronde Gendo è già un “padre di m****” e in più lo manda a morire praticamente ogni giorno. Quando arriva a Neo Tokyo-3, Shinji ha solamente intenzione di dire a suo padre che lo odia per averlo abbandonato ma quando capisce la responsabilità a cui è sottoposto e ai danni che gli altri subirebbero se se ne andasse, accetta di pilotare l’Eva per combattere gli Angeli.
Qui c’è un punto in comune tra Misato e Shinji. Anche Misato scappa dal ricordo del padre (morto per colpa degli Angeli) ma si innamora di un uomo come Kaiji che lo ricorda in tutto e per tutto. Lei stessa si arruola nella Nerv per prendere le distanze da lui, seppure anch’egli vi lavorasse, e conduce una guerra personale contro gli Angeli sui quali riversa il proprio rancore.
Inizialmente Shinji si limita ad eseguire gli ordini e quando Gendo inizia a lodarlo comincia inconsciamente a bramare la sua approvazione, piegandosi ad ogni sua richiesta. C’è da dire che Shinji soffre di scarsa autostima (quando gli fanno i complimenti si sente a disagio e li rigetta come non veritieri) ma allo stesso tempo è disperatamente dipendente dall’approvazione altrui.
Qui c’è una delle tante rappresentazioni del dilemma del porcospino in Neon Genesis Evangelion: Shinji teme il padre e lo odia per averlo abbandonato e manipolato ma desidera il suo contatto, allo stesso tempo Gendo è incapace di comunicare con lui e teme che aprendosi ai suoi sentimenti ne rimarrebbe ferito, per questo lo tiene a distanza.
Un altro esempio del teorema dei porcospini è il rapporto tra Shinji e Asuka, la quale spesso lo insulta. Asuka da una parte soffre quando Shinji inizia a migliorare rispetto a lei come pilota di EVA, dall’altra ricerca le sue attenzioni. Per quanto a parole lo maltratti e lo disprezzi, Auska gli manda continuamente segnali di interesse.
Entrambi infatti sono emotivamente immaturi e bramano l’affetto dell’altro senza riuscire a comunicare tra loro. C’è da dire che Asuka e Shinji sono comunque degli adolescenti che cercano di confrontarsi per la prima volta con i propri sentimenti, ma con il progredire della serie in Asuka crescono parallelamente il desiderio di amore e odio per il suo collega e rivale mentre, invece, Shinji è costantemente confuso dalla vita.
La “scelta” come soluzione al dilemma del porcospino
Hideaki Anno con Neon Genesis Evangelion sembra voler dare una possibile soluzione al dilemma del porcospino di Schopenhauer.
Ritsuko, parlando di Shinji, dice a Misato che fa tutto ciò che gli viene detto per semplificarsi la vita pur essendo chiaro che ciò non gli dà alcun significato né felicità. Misato nella serie arriva a criticare apertamente Shinji dicendogli che rischia di morire pilotando un Eva con questo atteggiamento e gli dice di smettere di dare peso a cosa pensano gli altri e di andarsene se non vuole essere lì. Ma Shinji non è in grado di affrontare questa sfida, pensa che racconta ad Asuka di non aver smesso di prendere le lezioni di violoncello perchè “nessuno gli aveva mai detto di farlo”.
Da una parte il conflitto interiore che vive Shinji lo porta a dubitare di avere una ragione per vivere e lo rende incapace di accettare le diverse sfaccettature di ciò che desidera come individuo singolo e in relazione agli altri. Dall’altra le ragioni nella reazioni di Misato stanno nel fatto che lei stessa non riesce ad affrontare il peso emotivo di torturare Shinji per costringerlo a lottare contro gli Angeli. In tutto ciò il pilota dell’Eva-01 sente di non ricevere nulla in cambio e incolpa proprio Misato. Essendo Shinji una persona che non sente di avere un posto nel mondo, è difficile per lui convincersi che salvare il mondo valga la pena. Che senso ha combattere e soffrire se alla fine sarà comunque infelice?
A un certo punto della serie entrambi si rendono conto che hanno sempre cercato di entrare in contatto. Misato capisce che Shinji semplicemente non sa come comunicare i propri sentimenti in modo diretto, mentre Shinji capisce che Misato lo ha sempre incoraggiato fin dall'inizio. Riescono ad entrare in connessione tra loro solo nel momento in cui imparano ad ascoltarsi e ad entrare in empatia, costruiscono in un certo senso il loro modo di stare più vicino.
Inoltre, la vita di Shinji fino alle parole di Misato non aveva senso, e solo quando il protagonista si trova ad affrontare la scelta, ad avere la libertà di ribellarsi, trova una soluzione all’insensatezza della vita e, capendo chi è realmente, anche al dolore che provano i porcospini di Schopenhauer.
Nel momento in cui associa la propria personalità alla sua identità di pilota di Eva, nel momento in cui sceglie chi essere e come vivere nelle relazioni, trae il significato dal suo dovere e riceve così uno scopo che prima gli mancava.
Hideaki Anno con Neon Genesis Evangelion, ma anche Schopenhauer con i suoi porcospini, cerca di rispondere a una serie di domande: perché ci allontaniamo dalle persone che amiamo? perché abbiamo tanta paura di essere feriti? perché è così difficile per chi soffre di ansia e depressione cercare l'aiuto degli altri?
Tutte domande che come società ci troviamo ad affrontare oggi come individui, figuriamoci quando dobbiamo affrontare sfide comuni come la crisi climatica. Oltre a ciò, anche di fronte ai numerosi casi di persone prive di relazioni e sempre più isolate, la psicologia contemporanea ha iniziato a studiare il binomio tra il forte bisogno di socialità degli esseri umani, l’enorme paura delle conseguenze associate dall’esclusione sociale e nell’affrontare il giudizio degli altri.
Il dilemma del porcospino sembra più che mai attuale e ci invita a riflettere su come sia importante creare spazi più sicuri per soddisfare l’aspettativa delle persone di vedere la propria voce ascoltata, riconosciuta e presa in considerazione. Ciò richiederebbe la capacità di saper coltivare la comprensione in modo da poter creare le precondizioni per soddisfare il bisogno di sentirsi parte di qualcosa, purtroppo troppo spesso è più facile ignorare ed evitare di curare le singole particolarità.
E tu, cosa ne pensi? Secondo te è impossibile per gli esseri umani raggiungere l’intimità senza essere feriti? Cosa può unire le persone o i gruppi all’interno di una società?
Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica.
Per approfondire il “dilemma del porcospino”:
Maner, J.K., DeWall, C.N., Baumeister, R.F., & Schaller, M. (2007). Does social exclusion motivate interpersonal reconnection? Resolving the 'porcupine problem.' Journal of Personality and Social Psychology, 92, 42–55.
Veit, W. (2018). Existential Nihilism: The Only Really Serious Philosophical Problem. Journal of Camus Studies, 211–232.
Freud, S., Group psychology and the analysis of the Ego. Cap. VI - Further problems and lines of work, in The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, vol 18, 1981, pp. 100-104.