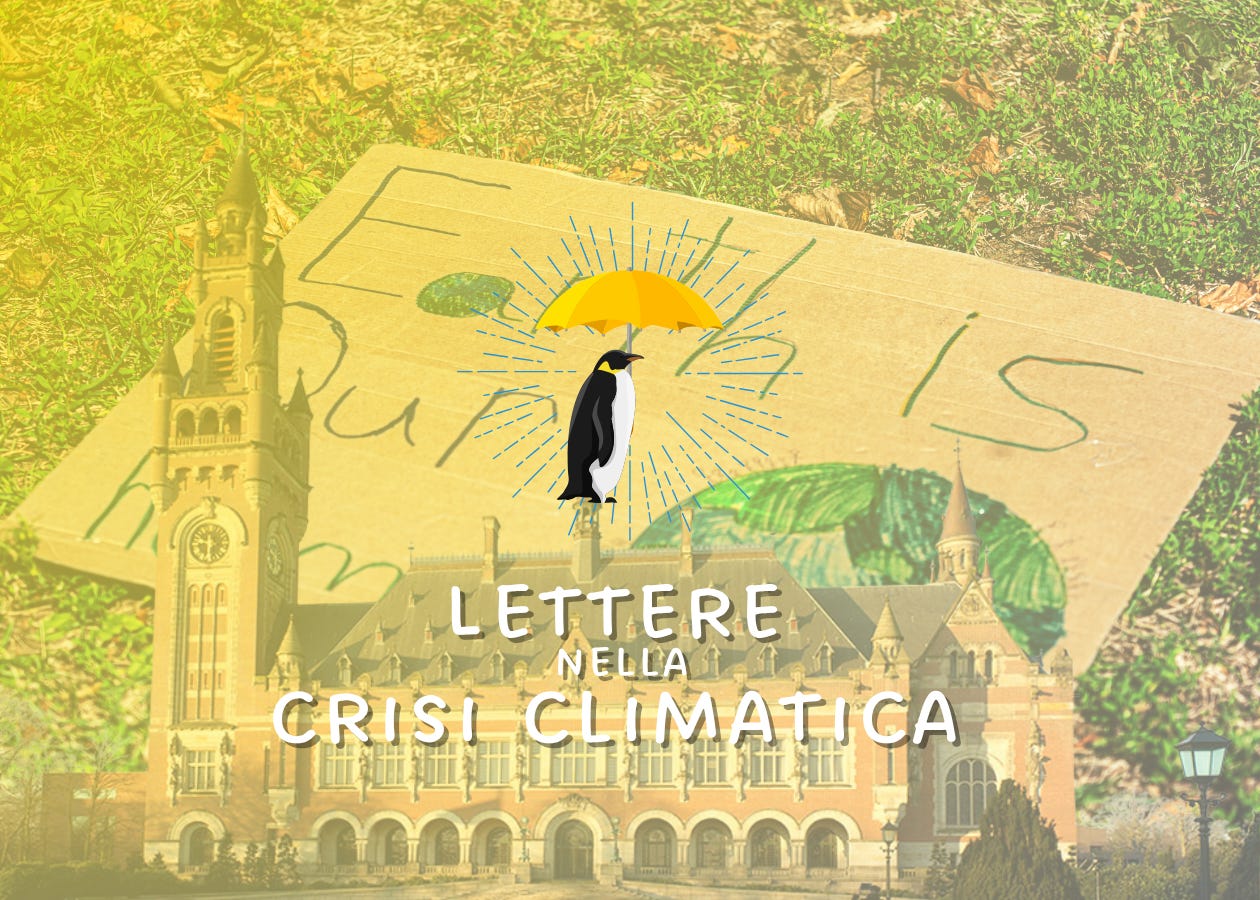La Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi nella crisi climatica
La Corte Internazionale di Giustizia ha emesso uno storico parere sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico
Il 23 luglio 2025 la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso il proprio parere consultivo sugli obblighi degli stati nel contesto della crisi climatica. Si tratta un parere storico in cui anche la Corte Internazionale di Giustizia riconosce che i cambiamenti climatici sono un “rischio universale esistenziale” causato “inequivocabilmente” dalle attività umane per cui gli Stati hanno l’obbligo legale vincolante di “prevenire e porre rimedio” al “danno climatico”.
Gli Stati non sono liberi di voltare le spalle alla crisi climatica e devono prevenire i danni significativi causati dalle emissioni, cooperare a livello internazionale per affrontare la crisi climatica, riconoscere le responsabilità storiche e le differenti capacità tra gli stati e garantire che il pianeta resti vivibile per le generazioni future.
Ora vediamo insieme cos’è e cosa dice il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici.
Che cos'è il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia?
La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, pensa che lo stesso statuto della Corte è allegato alla carta delle Nazioni Unite. Entrando a far parte dell’organizzazione internazionale si aderisce alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia, la quale emette sentenze vincolanti in caso di controversie tra Stati e rende pareri consultivi inerenti a questioni di diritto internazionale. Un parere consultivo è una risposta a una richiesta specifica di consulenza e chiarimenti sul significato e l'applicazione del diritto internazionale rispetto a una situazione particolare.
Stati e individui non possono rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia per un parere consultivo, questo può essere richiesto:
dall’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su tutte le questioni aperte di diritto internazionale
da altri organi o agenzie specializzate delle Nazioni Unite a condizione che siano autorizzati a farlo e che l’oggetto dello stesso rientri nella loro sfera di competenza
In passato le questioni trattate dalla Corte con i pareri consultivi hanno riguarda anche la liceità dell’uso di bombe atomiche (1996), la legalità della costruzione del muro di separazione israeliano nel Territorio palestinese occupato (2004) e la legittimità della dichiarazione d’indipendenza del Kosovo (2010).
Perché un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici?
La mancanza di chiarezza sugli obblighi degli Stati nel contesto della crisi climatica ha portato a una richiesta diretta da parte degli Stati attraverso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (attraverso la Risoluzione 77/276 adottata il 29 marzo 2023). Quest’ultima ha chiesto alla Corte di chiarire gli obblighi giuridici degli Stati in materia di cambiamenti climatici e le conseguenze per gli Stati che non rispettano questi obblighi. In questo modo la Corte Internazionale di Giustizia ha potuto stabilire che gli obblighi esistenti in materia di cambiamenti climatici alla luce del diritto internazionale e i diritti umani, nonché precisare le conseguenze giuridiche in caso di violazione di queste norme.
Cosa dice il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici?
La Corte Internazionale di Giustizia attraverso il parere consultivo ha risposto a due domande poste dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una relativa agli obblighi degli Stati secondo il diritto internazionale e una sul “cosa succede” se questi obblighi non vengono rispettati, sopratutto in caso di danni subiti dai Paesi in una maggiore condizione di vulnerabilità e dalle generazioni future.
Quali obblighi hanno gli Stati secondo il diritto internazionale per affrontare la crisi climatica?
La Corte nella sua analisi ripercorre numerosissimi atti internazionali, per questo non riporterò in modo esaustivo tutti i punti ma cercherò di darti una panoramica (anche se molto densa). Ad esempio la Corte, nell’individuare il diritto applicabile, riconosce che tra gli scopi della Carta delle Nazioni Unite vi è quello di utilizzare la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali e nell’affrontare problemi di interesse comune, tra questi vi rientrerebbe anche il cambiamento climatico. Tra i principali strumenti giuridici vengono inseriti quelli che disciplinano la risposta internazionale alla crisi climatica (l’UNFCCC, il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi), i principali trattati ambientali (come le convenzioni sul diritto del mare, della biodiversità, sull’ozono e sulla desertificazione) e gli strumenti di tutela dei diritti umani.
A tal proposito, contro le tesi degli Stati che ritengono debbano applicarsi solamente gli strumenti “di settore” sui cambiamenti climatici, la Corte osserva che un principio riconosciuto è che quando più norme riguardano una stessa questione devono, nella misura del possibile, essere interpretate in modo da dar luogo a un unico insieme di obblighi compatibili. In altre parole i trattati in materia di cambiamenti climatici, in generale, non prevalgono su altre norme di diritto internazionale, nè possono sostituire altre norme o principi eventualmente applicabili (come le norme consuetudinarie, i trattati sulla tutela dell’ambiente o sui diritti umani).
I principi guida e l’obbligo di due diligence degli Stati nell’affrontare la crisi climatica
Dal punto di vista del diritto internazionale consuetudinario, nel contesto dei cambiamenti climatici la Corte rinviene in particolare l’applicabilità dell’obbligo di prevenire danni significativi all'ambiente e l'obbligo di cooperare per la tutela dell'ambiente anche quando con riferimento al sistema climatico. Entrambi consistono in un obbligo “rigoroso” da parte degli Stati di agire con la dovuta diligenza (c.d. due diligence), ossia l’adozione al meglio delle proprie capacità di misure adeguate e, se necessario, precauzionali, che tengano conto delle informazioni scientifiche e tecnologiche, nonché delle norme e degli standard internazionali pertinenti. In particolare l’obbligo di cooperare, oltre a essere il fulcro della Carta delle Nazioni Unite e a essere ribadito nella Dichiarazione di Rio, è intrinsecamente legato al dovere di prevenire danni significativi all'ambiente, poiché gli sforzi individuali non coordinati degli Stati potrebbero non portare a risultati significativi. Entrambi gli obblighi possono servire anche da principio guida nell’interpretazione di altre norme. Gli elementi principali di tale dovere sono il danno ambientale da prevenire e la diligenza dovuta come standard di comportamento richiesto.
Affinché sorga l'obbligo di prevenzione, deve sussistere un rischio di danno significativo all'ambiente e tale obbligo esiste sia quando non è stato ancora causato alcun danno ma esiste il rischio di un danno significativo futuro, sia quando è già stato causato un danno e sussiste il rischio di un danno significativo ulteriore. Il fatto che un'attività costituisca un rischio di danno significativo dipende «sia dalla probabilità o dalla prevedibilità del verificarsi del danno, sia dalla sua gravità o entità» e dovrebbe quindi essere determinato da una valutazione combinata del rischio e del livello di danno. È necessario tenere conto dei rischi che le attività attuali potrebbero comportare in futuro, anche a lungo termine. In ogni caso maggiore è la probabilità e la gravità del danno possibile, più rigoroso è lo standard di condotta richiesto.
Ciò vale anche in caso di impatti cumulativi. La Corte prende infatti atto della valutazione dell'IPCC secondo cui il rischio di danni significativi al sistema climatico deriva dall'impatto cumulativo di varie attività umane. Il cambiamento climatico antropogenico è intrinsecamente una conseguenza delle attività intraprese sotto la giurisdizione o il controllo di tutti gli Stati, anche se i contributi storici e attuali dei singoli Stati differiscono in modo significativo. È la somma di tutte le attività che contribuiscono alle emissioni nel tempo, e non una specifica attività di emissione, a produrre il rischio di un danno significativo al sistema climatico. Ciò non significa che i comportamenti individuali che determinano emissioni non possano dar luogo all'obbligo di prevenire un danno transfrontaliero significativo, anche se tali attività sono di per sé irrilevanti dal punto di vista ambientale. Tuttavia, ciò significa che il rischio associato ai cambiamenti climatici è una conseguenza della combinazione di attività svolte da diversi Stati e che questi ultimi devono scongiurare il rischio attraverso una risposta coordinata e cooperativa.
La determinazione del danno al sistema climatico deve tenere conto delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, che attualmente si trovano nelle relazioni dell'IPCC. Sulla base di queste la Corte ritiene che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, tra cui l'aumento dei livelli di temperatura, l'innalzamento del livello del mare, i danni agli ecosistemi e sulla diversità biologica e gli eventi meteorologici estremi, indicano che l'accumulo di emissioni nell'atmosfera sta causando un danno significativo al sistema climatico e ad altre parti dell'ambiente. La questione se un danno specifico, o il rischio di un danno, a uno Stato costituisca un effetto negativo rilevante dei cambiamenti climatici deve essere valutata in concreto in ogni singola situazione o caso.
Come si valuta la dovuta diligenza di uno Stato?
Per valutare se uno Stato adempie con la dovuta diligenza ai propri obblighi, secondo la Corte Internazionale di Giustizia occorre che vi siano:
Norme e misure adeguate che comprendono, in modo non esaustivo, meccanismi normativi di mitigazione volti a conseguire la riduzione rapida, profonda e rapida e sostenuta delle emissioni necessarie per prevenire danni significativi al sistema climatico ma anche misure di adattamento climatico che riducono il rischio che si verifichino danni significativi. Secondo la Corte tali norme e misure devono disciplinare il comportamento degli operatori pubblici e privati soggetti alla giurisdizione o al controllo degli Stati ed essere accompagnate da meccanismi di applicazione e monitoraggio efficaci per garantirne l'attuazione.
Informazioni scientifiche e tecnologiche utili a valutare la probabilità e la gravità di possibili danni (indicando quindi il livello di diligenza richiesta) e che lo stato deve ricercare attivamente. A questo proposito, le relazioni dell'IPCC costituiscono una sintesi completa e autorevole delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sui cambiamenti climatici al momento della loro pubblicazione.
Presa in considerazione delle norme e degli standard internazionali pertinenti, ad esempio l’obbligo generale di prevenire danni significativi all'ambiente consiste in elementi sostanziali (ad esempio l'obbligo di adottare misure adeguate) ed elementi procedurali (ad esempio l'obbligo di notifica e consultazione), attraverso i quali gli Stati adempiono al loro dovere di diligenza nel prevenire danni transfrontalieri.
utilizzo di tutti i mezzi a propria disposizione, secondo la Corte, nel determinare le misure appropriate che uno Stato deve adottare, occorre tenere conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. Il carattere multifattoriale ed evolutivo dello standard di diligenza dovuta implica che, con lo sviluppo economico degli Stati e l'aumento delle loro capacità, aumentano anche i requisiti di diligenza.
adozione dell’approccio e principio precauzionale con le relative misure, gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per prevenire i danni qualora esistano prove scientifiche attendibili di un rischio di danno significativo ma in ogni caso non dovrebbero astenersi o ritardare l'adozione di misure preventive in caso di incertezza scientifica. La Corte afferma che secondo il principio 15 della Dichiarazione di Rio, in caso di minaccia di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere utilizzata come motivo per rinviare misure efficaci sotto il profilo dei costi volte a prevenire il degrado ambientale.
valutazione dei rischi e valutazione dell’impatto ambientale, l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza impone agli Stati non solo di adottare misure sostanziali, ma anche di compiere determinati passi procedurali. Tali obblighi procedurali sono distinti dagli obblighi di adottare misure sostanziali per prevenire i rischi. La Corte ritiene che i rischi posti dai cambiamenti climatici presentino alcune caratteristiche che possono influire sull'adeguatezza di determinate forme di valutazione del rischio ambientale. Pertanto può essere ragionevole che gli Stati effettuino le loro valutazioni del rischio causato dalle emissioni mediante procedure generali che coprono diverse forme di attività. Tali procedure generali non escludono che eventuali effetti specifici legati al clima debbano essere valutati nell'ambito delle VIA a livello delle singole attività proposte, ad esempio al fine di valutare i loro possibili effetti a valle.
Notifica e consultazione, la dovuta diligenza nella prevenzione di danni significativi all'ambiente implica talvolta anche l'obbligo degli Stati di notificare e consultare in buona fede gli altri Stati in merito ai rischi di effetti negativi della loro condotta. La Corte ritiene che, dato il carattere specifico dei processi che portano al cambiamento climatico, la notifica e la consultazione siano particolarmente giustificate quando un'attività incide in modo significativo sugli sforzi collettivi volti a far fronte ai danni al sistema climatico, come l'attuazione di cambiamenti politici in relazione allo sfruttamento delle risorse legate alle emissioni, o per quanto riguarda le informazioni necessarie per una cooperazione tra gli Stati.
Gli obblighi discendenti dai trattati sui Cambiamenti climatici
Nell’esaminare gli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, la Corte prende come riferimento tre strumenti giuridicamente vincolanti: l'UNFCCC, il protocollo di Kyoto e l'accordo di Parigi. Su questo viene notato che tra gli Stati vi sono opinioni divergenti sulla natura e la portata degli obblighi giuridici derivanti da questi trattati, con qualcuno che ritiene che tali sono stati concepiti da non essere onerosi o “addirittura” vincolanti. Un altro punto di disaccordo riguarda la questione se alcuni obblighi previsti dai trattati sui cambiamenti climatici, in particolare quelli previsti dall'accordo di Parigi, siano “obblighi di comportamento” o “obblighi di risultato”.
Su questo la Corte osserva che le varie distinzioni non sono necessariamente rigide che le diverse caratteristiche degli obblighi descritti possono sovrapporsi. Allo stesso modo non si può sostenere che un obbligo sia più oneroso dell’altro. Infine non tutte le disposizione dei trattati sui cambiamenti climatici si prestano a essere classificate in questo modo. La Corte però ricorda che gli obblighi di comportamento nel diritto internazionale dell'ambiente, come abbiamo visto prima, comportano un obbligo di agire con la dovuta diligenza, che impone agli Stati contraenti «di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione» al fine di adempiere ai propri obblighi internazionali. In ogni caso nell’interpretazione degli obblighi occorre in prima di tutto far riferimento ai principi fondamentali che permeano tutti e tre i trattati e che sono contenuti nell’articolo 3 dell’UNFCCC: 1. le responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità; 2. l'approccio o principio precauzionale, 3. lo sviluppo sostenibile, 4. l'equità e 5.l'equità intergenerazionale.
Nell'interpretare i propri obblighi ai sensi dei trattati sui cambiamenti climatici, oltre a questi principi guida e alle norme consuetudinarie, gli Stati possono far riferimento alle decisioni pertinenti degli organi direttivi di tali trattati, che sono la COP dell'UNFCCC e la COP che funge da riunione delle Parti (le cosiddette “CMA”) del Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi. La Corte osserva che, in determinate circostanze, le decisioni di tali organi hanno determinati effetti giuridici. In primo luogo, quando il trattato lo prevede, le decisioni delle COP possono creare obblighi giuridicamente vincolanti per le parti (come nel caso della comunicazione dei Nationally Determined Contributions all’articolo 4, paragrafo 8). In secondo luogo, possono costituire accordi successivi ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nella misura in cui tali decisioni esprimono un accordo sostanziale tra le parti in merito all'interpretazione del trattato e devono quindi essere prese in considerazione come mezzi di interpretazione dei trattati sui cambiamenti climatici.
La Corte, non esaminando in dettaglio tutte le disposizioni, individua tre macro ambiti di obblighi su: 1. mitigazione, 2. adattamento ai cambiamenti climatici, 3. cooperazione internazionale.
Gli obblighi degli Stati sulla mitigazione delle cause dei cambiamenti climatici
La Corte ritiene che la mitigazione sia al centro dell'UNFCCC, ossia l’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello che impedisca pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico. La Convenzione quadro mira a raggiungere il suo obiettivo di mitigazione in due modi: riducendo le fonti (sources) di rilascio o rafforzando e potenziando le fonti di assorbimento (sinks) dei gas serra (GHG).
Tra gli obblighi vincolanti previsti dalla UNFCCC, con annessa procedura di attuazione, sulla mitigazione ai cambiamenti climatici sono presenti all’articolo 4 e sono:
elaborazione, aggiornamento periodico, pubblicazione e messa a disposizione della Conferenza delle Parti inventari nazionali delle emissioni
formulazione, attuazione, pubblicazione e aggiornamento regolarmente programmi nazionali e, se del caso, regionali contenenti misure volte a mitigare i cambiamenti climatici
comunicazione alla Conferenza delle Parti delle informazioni relative all'attuazione
Vi sono poi obblighi dedicati alle Parti che sono “paesi sviluppati” o inclusi nell’allegato I che prevedono:
l’adozione di politiche nazionali e misure corrispondenti per mitigare i cambiamenti climatici
la comunicazione di informazioni dettagliate sulle politiche e sulle misure adottate con l'obiettivo di riportare, individualmente o congiuntamente, le emissioni antropogeniche ai livelli del 1990
il coordinamento di strumenti economici e amministrativi pertinenti elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione
individuazione e riesame periodico delle proprie politiche e pratiche
Possiamo qui trovare sia obblighi di risultato, sia obblighi di comportamento, ma l’aspetto importante è che sono correlati tra loro. La Corte però ricorda che entrambi i tipi di obblighi possono comportare la responsabilità di uno Stato per la violazione dell'obbligo pertinente. Ad esempio, nel caso di un obbligo di comportamento, uno Stato agisce in modo illecito se non utilizza tutti i mezzi a sua disposizione per conseguire l'obiettivo previsto dall'obbligo, ma non agisce in modo illecito se adotta tutte le misure a sua disposizione al fine di adempiere all'obbligo, anche se l'obiettivo desiderato non è stato alla fine raggiunto. Invece, nel caso di un obbligo di risultato, uno Stato agisce in modo illecito se non ottiene il risultato richiesto dall'obbligo. Allo stesso tempo, non si può affermare che un obbligo di risultato, come l'obbligo di «adottare politiche nazionali e misure corrispondenti per mitigare i cambiamenti climatici», sia adempiuto semplicemente con l'adozione di qualsiasi politica e l'adozione di misure corrispondenti. Per ottemperare a tale obbligo di risultato, le politiche adottate e le misure adottate devono essere tali da consentire il raggiungimento dell'obiettivo richiesto. In altre parole, la Corte chiarisce che l'adozione di una politica e l'adozione di misure correlate, come mera formalità, non sono sufficienti per adempiere all'obbligo di risultato.
Per quanto riguarda gli obblighi di mitigazione discendenti dall’Accordo di Parigi la Corte osserva che sono enunciati all’articolo 4. Il paragrafo 1 stabilisce che, al fine di raggiungere l'obiettivo di temperatura fissato all'articolo 2, “le Parti mirano a raggiungere il picco globale delle emissioni di gas a effetto serra il più presto possibile [...] e a intraprendere rapide riduzioni in seguito”, in modo da raggiungere emissioni nette pari a zero entro la seconda metà del secolo. Su questo viene evidenziato che quanto enunciato nell’articolo costituisce, oltre all'oggetto e allo scopo dell'accordo, il «contesto» rilevante per l'interpretazione di altri obblighi contenuti in altre parti dell'accordo di Parigi. L'articolo 5 dell'Accordo di Parigi precisa i mezzi per raggiungere l’obiettivo l’obiettivo Net Zero stabilendo che «le Parti adottano misure per conservare e migliorare, se del caso, i pozzi e i serbatoi di assorbimento dei gas a effetto serra [...] , comprese le foreste». L'Accordo di Parigi rafforza quindi gli obblighi contenuti all'articolo 4 dell'UNFCCC e nel testo della convenzione vi sono ulteriori obblighi relativi ai Nationally Determined Contributions (NDCs).
Gli Stati hanno l’obbligo vincolante di preparare, comunicare ogni 5 anni e mantenere i NDCs che intende realizzare e perseguono misure di mitigazione interne, con l'obiettivo di realizzare gli obiettivi di tali contributi. Si tratta di un obbligo sia di natura procedurale, sia di risultato: la mancata elaborazione, comunicazione e mantenimento dei successivi NDC, la mancata rendicontazione e registrazione degli stessi costituirebbero una violazione degli stessi. Anche qui la semplice elaborazione formale non è sufficiente per adempiere agli obblighi.
Molti stati hanno sostenuto che il contenuto delle NDC è «autodefinito» o soggetto alla «discrezionalità» delle parti, questo dipenderebbe dall’interpretazione dell’articolo che dovrebbe essere effettuata in buona fede. Di per sé la disposizione non stabilisce requisiti per il contenuto delle NDC, né indica che le parti abbiano una discrezionalità illimitata nella loro elaborazione. Tuttavia, la Corte rileva che l'articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo di Parigi stabilisce alcune aspettative e norme che si applicano alle parti nella preparazione dei loro NDC. Il testo dell’articolo (in cui si utilizza il termine “saranno”) suggerisce un aspettativa su come deve essere un NDC, ossia a ogni aggiornamento devono costituire un progresso e riflettere l'ambizione più elevata possibile di uno Stato.
Secondo la Corte l’obbligo prevede che gli NDC di uno stato devono diventare “più impegnativi nel tempo”, seguendo anche il principio della prevenzione dei danni significativi all'ambiente e l’esercizio della dovuta diligenza. La “massima ambizione possibile” non è poi discrezionale ma deve essere interpretata nel suo contesto (alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato, oltre che dei principi guida e del diritto consuetudinario). In questo senso il contenuto degli NDC deve, in adempimento degli obblighi dell'Accordo di Parigi, essere in grado di contribuire adeguatamente al raggiungimento dell'obiettivo di temperatura, quello di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C senza superarlo, che richiede la riduzione delle emissioni del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035 rispetto al livello del 2019 e il raggiungimento Net Zero entro il 2050. Inoltre vi sono degli obblighi di trasparenza, previsti nell’articolo 4 paragrafo 8, secondo cui nella comunicazione degli NDC gli Stati devono fornire le informazioni necessarie per garantire chiarezza, trasparenza e comprensione in modo da promuovere «l'integrità ambientale, la trasparenza, l'accuratezza, la completezza, la comparabilità e la coerenza» e garantire «l'assenza di doppio conteggio».
Infine, l'obbligo delle parti di «attuare misure di mitigazione nazionali» è di natura sostanziale e gli Stati sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza nell'adottare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati nei loro successivi NDC. La Corte ritiene che tale obbligo imponga agli Stati di essere proattivi e di perseguire misure ragionevolmente idonee a realizzare gli NDC da essi fissati. Tali misure possono includere l'istituzione di un sistema nazionale, comprese la legislazione, le procedure amministrative e un meccanismo di applicazione, e l'esercizio di un'adeguata vigilanza per garantire l'efficace funzionamento di tale sistema, al fine di conseguire gli obiettivi dei propri NDC. Lo standard di diligenza dovuto in relazione all'obbligo di adottare misure di mitigazione a livello nazionale deve essere rigoroso, in quanto le migliori conoscenze scientifiche disponibili indicano che «i rischi e gli impatti negativi previsti, nonché le perdite e i danni connessi ai cambiamenti climatici, aumentano con ogni incremento del riscaldamento globale.
Gli obblighi degli Stati per l’adattamento climatico
La Corte Internazionale di Giustizia osserva che l’adattamento ai cambiamenti climatici, insieme alla mitigazione, è un importante settore di intervento per gli Stati anche nell'ambito dell’UNFCCC. Diverse disposizioni della Convenzione quadro fanno riferimento agli obblighi in materia di adattamento climatico.
Ad esempio, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) prevede che tutti gli Stati parte “formulino, attuino, rendano pubblici e aggiornino regolarmente programmi nazionali e, se del caso, regionali contenenti misure volte a [...] facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici”. La lettera e) stabilisce l'obbligo per le parti di “cooperare nella preparazione all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; sviluppare ed elaborare piani adeguati e integrati per la gestione delle zone costiere, delle risorse idriche e dell'agricoltura, nonché per la protezione e il ripristino delle zone colpite dalla siccità e dalla desertificazione nonché dalle inondazioni”. La lettera f) impone poi agli Stati di “tenere conto, nella misura del possibile, delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nelle loro politiche e azioni sociali, economiche e ambientali pertinenti”. Gli Stati devono a tal proposito utilizzare metodi adeguati al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o le misure di adattamento potrebbero avere sull'economia, sulla salute pubblica o sulla qualità dell'ambiente.
L'articolo 4, paragrafo 4, dell'UNFCCC prevede che le parti dell'allegato II «assistano» i paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel sostenere i costi dell'adattamento a tali effetti negativi. Il paragrafo 8 obbliga gli Stati a tenere pienamente conto, nell'attuazione dei loro impegni, “delle azioni necessarie nell'ambito della Convenzione, comprese quelle relative al finanziamento, all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, per soddisfare le esigenze e le preoccupazioni specifiche delle parti che sono paesi in via di sviluppo derivanti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o dall'impatto dell'attuazione delle misure di risposta”.
Anche l’Accordo di Parigi prevede degli obblighi sull’adattamento climatico e, nello specifico, mira ad aumentare la “capacità delle parti di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e di promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici” (articolo 2, paragrafo 1, lettera b)). Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo prevede che le parti riconoscono che l'attuale necessità di adattamento climatico è significativa e che livelli più elevati di mitigazione possono ridurre la necessità di ulteriori sforzi di adattamento, e che maggiori esigenze di adattamento possono comportare maggiori costi di adattamento climatico.
Vi sono poi delle disposizioni che non impongono agli Stati obblighi giuridicamente vincolanti, ma al contempo riflettono una visione comune delle parti sulla natura del problema affrontato. Ad esempio all’articolo 7 gli stati riconoscono che:
l'adattamento climatico è una sfida globale
le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero seguire un approccio guidato dai paesi, sensibile alle questioni di genere, partecipativo e pienamente trasparente
l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale per gli sforzi di adattamento.
Secondo la Corte, tali disposizioni forniscono un contesto per l'interpretazione di altre disposizioni che contengono obblighi. La Corte ritiene che obblighi specifici in materia di adattamento siano contenuti nell'articolo 7, paragrafo 9, dell'Accordo di Parigi e che impone l'obbligo giuridicamente vincolante di intraprendere azioni di pianificazione dell'adattamento. Gli obblighi di adattamento ai cambiamenti climatici secondo la Corte Internazionale di Giustizia includono:
l'attuazione di azioni, impegni e/o sforzi di adattamento
la formulazione e l'attuazione di piani nazionali di adattamento
la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità, al fine di formulare azioni prioritarie determinate a livello nazionale, tenendo conto delle persone, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili
il monitoraggio, la valutazione e l'apprendimento dai piani, dalle politiche, dai programmi e dalle azioni di adattamento
il rafforzamento della resilienza dei sistemi socioeconomici ed ecologici
La Corte ritiene che l'adempimento degli obblighi di adattamento delle parti debba essere valutato in base a uno standard di diligenza dovuta. Spetta quindi agli Stati di adottare misure adeguate che siano in grado di «migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Anche in questo caso le parti devono compiere ogni sforzo, in linea con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, al fine di raggiungere gli obiettivi. A questo proposito, la Corte osserva che l'IPCC ha rilevato nel 2023 che l'adattamento è una sfida particolarmente urgente nella risposta ai cambiamenti climatici e che esistono opzioni di adattamento efficaci per ridurre i rischi climatici in determinati contesti, quali il ripristino degli ecosistemi, la creazione di sistemi di allerta precoce e infrastrutture che rafforzano la resilienza. Ad avviso della Corte Internazionale di Giustizia tali opzioni, insieme ad altre, se attuate dagli Stati potrebbero soddisfare gli obblighi di adattamento. Infine, la Corte osserva che gli obblighi di adattamento previsti dall'accordo di Parigi integrano gli obblighi di mitigazione nella prevenzione e nella riduzione delle conseguenze dannose dei cambiamenti climatici. Lo stesso Accordo di Parigi riconosce esplicitamente tale interconnessione.
Gli obblighi degli Stati di cooperazione e assistenza
Nell’ambito dell’UNFCCC la Corte Internazionale di Giustizia identifica l’obbligo per gli Stati, sancito dall’articolo 4, di cooperare in diversi settori per quanto riguarda lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, compreso il trasferimento di tecnologie, pratiche e processi che controllano, riducono o prevengono le emissioni e migliorano l’adattamento climatico. La Convenzione richiede inoltre la cooperazione, lo scambio di informazioni e la promozione della ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica, giuridica e di altro tipo, nonché nell'istruzione, nella formazione e nella sensibilizzazione del pubblico in materia di cambiamenti climatici anche facilitando “la partecipazione del pubblico alla lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti e all'elaborazione di risposte adeguate” (articolo 6, lettera a), punto iii)).
La Corte ritiene che la cooperazione internazionale sia indispensabile nell’ambito dei cambiamenti climatici e che l'obbligo consuetudinario di cooperare per la protezione dell'ambiente si rifletta in diverse disposizioni dei trattati sui cambiamenti climatici. Anche in questo caso la Corte afferma che il dovere di cooperare è un obbligo di comportamento, il cui adempimento è valutato in base a uno standard di diligenza. In questo contesto, una cooperazione in buona fede implicherebbe tenere conto degli orientamenti forniti dalle decisioni della COP in materia di trasferimenti finanziari, trasferimenti di tecnologia e sviluppo delle capacità. Le linee guida, i quadri e i meccanismi adottati dalle decisioni della COP contribuiscono all'efficace attuazione delle disposizioni dell'UNFCCC.
Allo stesso modo la Corte osserva che l'Accordo di Parigi stabilisce obblighi di cooperazione in relazione a settori specifici, quali l'adattamento climatico e le perdite e i danni (loss and damage) agli articoli 7 e 8. Inoltre, l'articolo 12 stabilisce l'obbligo di cooperare nell'adozione di misure, se del caso, per migliorare l'istruzione, la formazione, la sensibilizzazione del pubblico, la partecipazione del pubblico e l'accesso del pubblico all'informazione in materia di cambiamenti climatici. Per la Corte Internazionale di Giustizia tali obblighi sussistono per gli Stati sia in base al diritto internazionale convenzionale (come nel caso della UNFCCC e dell’Accordo di Parigi), sia in base al diritto internazionale consuetudinario. Questi obblighi coesistenti si informano a vicenda e la Corte ritiene che l'obbligo consuetudinario di cooperare per la protezione dell'ambiente rafforzi gli obblighi di cooperazione previsti dal trattato ai sensi dell'Accordo di Parigi.
Per quanto riguarda la portata dell'obbligo di cooperare attraverso la fornitura di assistenza finanziaria, come la riduzione del debito delle parti in via di sviluppo, la Corte osserva che gli Stati sono liberi di scegliere i mezzi di cooperazione, purché tali mezzi siano compatibili con gli obblighi di buona fede e di diligenza. Sostanzialmente non ritiene necessario privilegiare una forma di cooperazione rispetto a un'altra. La Corte ritiene tuttavia che le principali forme di cooperazione previste dall'Accordo di Parigi siano l'assistenza finanziaria, il trasferimento di tecnologie e lo sviluppo di capacità, in particolare per la mitigazione, l’adattamento ai cambiamenti climatici e le perdite e i danni.
Cosa dice il parere consultivo sui diritti umani?
La Corte Internazionale di Giustizia nel determinare se il diritto internazionale dei diritti umani fa parte del diritto applicabile afferma che la tutela dell’ambiente e dei diritti umani sono state riconosciute come interdipendenti almeno a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. In tempi più recenti anche l’Accordo di Parigi del 2015 e la giurisprudenza di numerosi tribunali regionali, come la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio nel caso KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera), hanno riconosciuto l'interrelazione tra gli obblighi in materia di diritti umani e le norme relative alla protezione dell'ambiente naturale. Alla luce di ciò, la Corte ritiene che i trattati fondamentali in materia di diritti umani, compresi il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR») del 16 dicembre 1966, nonché i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale consuetudinario, costituiscano parte integrante del diritto applicabile.
La Corte osserva che gli Stati hanno l'obbligo, ai di rispettare, tutelare e garantire il godimento dei diritti umani degli individui e dei popoli e che tale obbligo non è limitato a specifici settori di attività. In particolare l'ambiente è il fondamento della vita umana, da cui dipendono la salute e il benessere delle generazioni presenti e future, pertanto la sua tutela è una condizione preliminare per il godimento dei diritti umani, la cui promozione è uno degli scopi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. la Corte ritiene che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici possano compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani.
Come affermato nel preambolo dell’Accordo di Parigi, i cambiamenti climatici sono una preoccupazione comune dell'umanità e che gli Stati nell'adottare misure farvi fronte dovrebbero rispettare, promuovere e tenere conto dei rispettivi obblighi in materia di diritti umani, diritto alla salute, diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in condizione di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, della parità di genere, dell'emancipazione delle donne e dell'equità intergenerazionale. La Corte, senza pretesa di esaustività, ripercorre alcuni di questi diritti, come il diritto alla vita e il diritto alla salute, e alcune delle più importati pronunce dei Treaty Bodies (qui trovi uno studio che avevo fatto qualche anno fa).
Tra gli aspetti più interessanti, vi è il fatto che la Corte ritiene che le condizioni derivanti dai cambiamenti climatici possono mettere in pericolo la vita delle persone possono indurle a cercare rifugio in un altro paese o impedire loro di tornare nel proprio. Secondo la Corte, gli Stati hanno l'obbligo, in virtù del principio di non respingimento, di garantire che non sussistano motivi fondati per ritenere che vi sia un rischio reale di danno irreparabile al diritto alla vita in violazione dell'articolo 6 dell'ICCPR se le persone sono rimpatriate nel loro paese d'origine. Segnando un punto di svolta importante per quanto riguarda il tema delle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici.
Oltre a ciò la Corte richiama la Dichiarazione congiunta sui “Diritti umani e cambiamenti climatici” del 16 settembre 2019 e la Relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sul rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani del 15 gennaio 2009 per affermare che nell'adottare misure per affrontare i cambiamenti climatici, gli stati devono rispettare, promuover e prendere in considerazione i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in condizioni di vulnerabilità. In particolare, le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero essere “concepite e attuate in conformità con i principi dei diritti umani di uguaglianza sostanziale e non discriminazione, partecipazione e empowerment, responsabilità e accesso alla giustizia, trasparenza e dello Stato di diritto” (Raccomandazione generale n. 37 sulle dimensioni di genere della riduzione del rischio di catastrofi nel contesto dei cambiamenti climatici, 7 marzo 2018).
La Corte Internazionale di Giustizia, inoltre, ritiene che un ambiente pulito, sano e sostenibile sia una condizione preliminare per il godimento di molti diritti umani, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute e il diritto a un tenore di vita adeguato, compreso l'accesso all'acqua, al cibo e all'alloggio. Il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile deriva dall'interdipendenza tra i diritti umani e la tutela dell'ambiente. Di conseguenza, nella misura in cui gli Stati parte dei trattati sui diritti umani sono tenuti a garantire l'effettivo godimento di tali diritti, è difficile vedere come tali obblighi possano essere adempiuti senza garantire al contempo la protezione del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile in quanto diritto umano. Il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile è quindi inerente al godimento degli altri diritti umani.
Tenuto conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul godimento dei diritti umani, la Corte ritiene che il pieno godimento dei diritti umani non possa essere garantito senza la tutela del sistema climatico e di altre componenti dell'ambiente. Pertanto gli Stati devono adottare misure per tutelare il sistema climatico anche per garantire il godimento dei diritti umani. Tali misure possono includere, tra l'altro, l'adozione di misure di mitigazione e adattamento climatico, tenendo debitamente conto della protezione dei diritti umani, l'adozione di norme e leggi e la regolamentazione delle attività degli attori privati.
Nell'interpretazione degli obblighi derivanti dai trattati sui cambiamenti climatici, anche alla luce dell’interdipendenza con gli obblighi derivanti dai diritti umani, deve far riferimento a una serie di principi come quello dello sviluppo sostenibile, delle responsabilità comuni ma differenziate, dell’equità, dell’equità intergenerazionale, della precauzione e del “chi inquina paga”. Sebbene tali principi non costituiscano obblighi autonomi nell'ambito del quadro dei trattati sui cambiamenti climatici, essi guidano l'interpretazione degli obblighi derivanti dai trattati. Ad esempio le considerazioni relative all’equità intergenerazionale devono svolgere un ruolo infra legem, senza sostituire o superare i limiti del diritto applicabile. Il dovuto rispetto degli interessi delle generazioni future e delle implicazioni a lungo termine dei comportamenti sono considerazioni di equità che devono essere prese in considerazione quando gli Stati contemplano, decidono e attuano politiche e misure in adempimento dei loro obblighi ai sensi dei trattati pertinenti e del diritto internazionale consuetudinario.
Cosa succede agli Stati se non rispettano gli obblighi climatici, soprattutto per i danni subiti dai Paesi in una maggiore condizione di vulnerabilità e dalle generazioni future?
Nel parere consultivo la Corte Internazionale di Giustizia si trova ad affrontare le caratteristiche particolari della crisi climatica per chiarire le questioni relative alla responsabilità degli Stati (ossia cosa accade se questi non adempio agli obblighi che abbiamo visto). La Corte ricorda che il cambiamento climatico è un fenomeno altamente complesso e multiforme, con una natura e portata senza precedenti, che comporta possibili responsabilità per più Stati su lunghi periodi di tempo.
Ciò è dovuto al fatto che le concentrazioni di emissioni non sono prodotte da una singola attività o da un gruppo di attività identificabili o associate a uno Stato o a determinati Stati. Inoltre, sono gli effetti collettivi e aggregati a causare danni al sistema climatico. Tuttavia gli Stati hanno contribuito in misura significativamente diversa alla concentrazione di gas serra nell'atmosfera e sono colpiti in modo diverso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Uno dei problemi che si pone nella crisi climatica è legato alla temporalità, la violazione di uno degli obblighi che abbiamo visto non si verifica necessariamente attraverso un'azione o un'omissione temporalmente circoscritta. La valutazione della portata temporale della violazione di un singolo obbligo può essere effettuata solamente su un caso concreto, per questo la Corte si concentra sulle questioni generali di attribuzione e causalità.
Sulla questione dell’attribuzione la Corte ritiene che, in linea di principio, le norme sulla responsabilità degli Stati di diritto internazionale consuetudinario siano in grado di affrontare una situazione in cui esiste una pluralità di Stati danneggiati o responsabili. Pertanto, nel contesto dei cambiamenti climatici, la Corte ritiene che ciascuno Stato leso possa invocare separatamente la responsabilità di ogni Stato che abbia commesso un fatto internazionalmente illecito che abbia causato un danno al sistema climatico e ad altre parti dell'ambiente. E quando più Stati sono responsabili dello stesso fatto internazionalmente illecito, la responsabilità di ciascuno Stato può essere invocata in relazione a tale fatto.
Sulla questione relativa al nesso di causalità del danno, la Corte osserva che non è un requisito per la determinazione della responsabilità in quanto tale. Per accertare la responsabilità di uno Stato è necessario che vi sia un fatto internazionalmente illecito e che esso sia attribuibile a uno Stato, indipendentemente dal fatto che il fatto causi o meno un danno. Il nesso di causalità è un concetto giuridico che svolge un ruolo nella determinazione della riparazione. Per quanto riguarda l'applicazione di tale standard giuridico nel contesto dei cambiamenti climatici, la Corte osserva che la causalità comporta due elementi distinti:
Se un determinato evento o tendenza climatica possa essere attribuito ai cambiamenti climatici antropogenici;
in che misura il danno causato dai cambiamenti climatici possa essere attribuito a un determinato Stato o gruppo di Stati
Sul primo punto, ad esempio, il rapporto di sintesi dell'IPCC del 2023 include dati che collegano chiaramente il contributo umano al cambiamento climatico all'aumento osservato delle ondate di calore, delle inondazioni e della siccità. Per quanto riguarda il secondo invece deve essere determinato nel caso concreto. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che, sebbene il nesso causale tra le azioni o omissioni illecite di uno Stato e il danno derivante dai cambiamenti climatici sia più tenue rispetto al caso delle fonti locali di inquinamento, ciò non significa che l'identificazione di un nesso causale sia impossibile nel contesto dei cambiamenti climatici. Di conseguenza significa semplicemente che il nesso causale deve essere stabilito caso per caso.
La Corte, inoltre, osserva che tutti gli Stati abbiano un interesse comune alla protezione dei beni comuni globali come l'atmosfera e l'alto mare. Di conseguenza, gli obblighi degli Stati relativi alla protezione del sistema climatico e di altre parti dell'ambiente dalle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra, in particolare l'obbligo di prevenire danni transfrontalieri significativi ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, sono obblighi erga omnes (“tra tutti”). Esiste tuttavia una differenza tra la posizione degli Stati lesi o degli Stati particolarmente colpiti, da un lato, e quella degli Stati non lesi, dall'altro, per quanto riguarda la disponibilità dei rimedi. Mentre uno Stato non leso può presentare una richiesta nei confronti di uno Stato che ha violato un obbligo collettivo, esso non può chiedere un risarcimento per sé stesso. Esso può invece solo chiedere la cessazione dell'atto illecito e assicurazioni e garanzie di non ripetizione, nonché l'adempimento dell'obbligo di riparazione nell'interesse dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato.
Infine la Corte riconosce che è ben stabilito che ogni fatto illecito internazionale di uno Stato comporta la responsabilità internazionale di tale Stato. Nel contesto dei cambiamenti climatici, l'atto internazionalmente illecito può variare dalla violazione di obblighi convenzionali, come l'obbligo procedurale di uno Stato di preparare, comunicare o attuare i NDC ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo di Parigi, alla violazione di obblighi di diritto internazionale consuetudinario, come l'omessa regolamentazione delle emissioni da parte di uno Stato nell'ambito del suo dovere di diligenza per prevenire danni significativi, o la mancata conduzione di VIA. Insomma tutti quegli obblighi che abbiamo già visto.
Non potendo scendere nei singoli casi particolari, a titolo di osservazione generale la Corte rileva che le violazioni di tali obblighi possono dar luogo all'intera gamma di conseguenze giuridiche previste dal diritto della responsabilità degli Stati, come ad esempio:
il dovere di adempimento, che non si estingue con la violazione
il dovere di cessazione del fatto illecito e di non ripetizione, per cui lo Stato deve impiegare tutti i mezzi a disposizione
il dovere di riparazione in caso dell’esistenza di un danno nei confronti di uno Stato. Questa può avvenire attraverso diversi rimedi come la restituzione (che comporta il ripristino della situazione esistente prima che fosse commesso l'atto illecito), il risarcimento (qualora la restituzione risulti materialmente impossibile, gli Stati responsabili hanno l'obbligo di risarcire il danno) o la soddisfazione (che dipende dal caso e che potrebbe assumere forme diverse, dalle dichiarazioni pubbliche ad azioni di sensibilizzazione)
Quali sono i possibili effetti futuri del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia?
Se sei arrivato a leggere fino a qui ti ringrazio per il tuo interesse sul parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia e ti chiedo se puoi lasciare un commento, in questo modo saprò che sei arrivata fin qui e sarebbe stupendo se condividessi un pensiero sull’utilità di questo contenuto.
Prima di concludere questa Lettera nella crisi climatica, volevo però riportare l’aspetto che più mi ha colpito di questo parere consultivo. La Corte internazionale di giustizia ha infatti concluso il parere ricordando che le questioni sulla crisi climatica sollevate dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite rappresentano più di un problema giuridico: riguardano un problema esistenziale di proporzioni planetarie che mette in pericolo tutte le forme di vita e la salute stessa del nostro pianeta.
Devo essere sincero, in un periodo storico in cui avevo iniziato a ritenere inutile il fatto di avere un master in diritti umani, il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sembra accendere un faro nell’oscurità per il pianeta, i diritti umani e le generazioni future. Questo parere conferisce un grande potere per lottare contro l’inerzia dei Governi nella crisi climatica, se non è così almeno ci da uno strumento in più che prima non avevamo.
Il diritto internazionale ha un ruolo importante ma in ultima analisi limitato nella risoluzione della crisi climatica. Come dice la Corte Internazionale di Giustizia, una soluzione completa a questo problema “arduo e autoinflitto” richiede il contributo di tutti i campi del sapere umano, che si tratti di diritto, scienza, economia o altro. E prosegue dicendo che “una soluzione duratura e soddisfacente richiede la volontà e la saggezza dell'umanità – a livello individuale, sociale e politico – per cambiare le nostre abitudini, i nostri comfort e il nostro attuale stile di vita al fine di garantire un futuro a noi stessi e a coloro che verranno dopo di noi”.
Tuttavia anche se i pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia non sono giuridicamente vincolanti, questi sono l’interpretazione autorevole della più importante Corte internazionale e riflettono lo stato attuale del diritto internazionale e la sua interpretazione. Il parere consultivo darà forma al diritto internazionale in materia di cambiamento climatico per i prossimi decenni perchè definisce con precisione in che modo gli Stati sono tenuti ad affrontare il cambiamento climatico ai sensi del diritto internazionale e quali sono le loro varie responsabilità. Gli Stati nella pratica sono vincolati dal modo in cui il diritto internazionale potrà essere interpretato sulla base di questo parere. Inoltre, il fatto che 99 Stati e 13 organizzazioni internazionali, tra cui i principali responsabili dell'inquinamento climatico come gli Stati Uniti, abbiano collaborato nella consultazione della Corte dimostra l'autorità e la legittimità del parere e mette in evidenza il vasto sostegno di cui essa gode da parte della comunità internazionale.
Come potrà essere usato in futuro? Semplice, il ragionamento della Corte internazionale di giustizia nel parere consultivo può contribuire a risolvere future controversie tra Stati nel contesto dei cambiamenti climatici. Può inoltre fornire a coloro che subiscono danni a causa dei cambiamenti climatici un'ulteriore base giuridica per ritenere gli Stati responsabili del mancato adempimento dei loro obblighi in materia di clima ai sensi del diritto dei diritti umani e di altro diritto internazionale. Insomma, potrà essere usato anche dai giudici nazionali nell’ambito delle Climate Change Litigation (pensa a “Giusta Causa” e a “Giudizio Universale” in Italia!).
Con il parere consultivo la Corte partecipa alle attività delle Nazioni Unite e della comunità internazionale con l'auspicio che le sue conclusioni consentano al diritto di informare e guidare l'azione sociale e politica volta ad affrontare l'attuale crisi climatica. Anche per questo abbiamo il dovere, come società civile, di diffondere i contenuti di questo Parere e far si che informi ogni nostra azione e richiesta al decisore politico. Nel frattempo non ci resta che pensare alla prossima grande prova, la COP30 in Brasile che si terrà a Novembre 2025!
E tu, cosa ne pensi? Quale è per te il valore del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia? Come potrebbe essere utile nell’affrontare la crisi climatica?
Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica