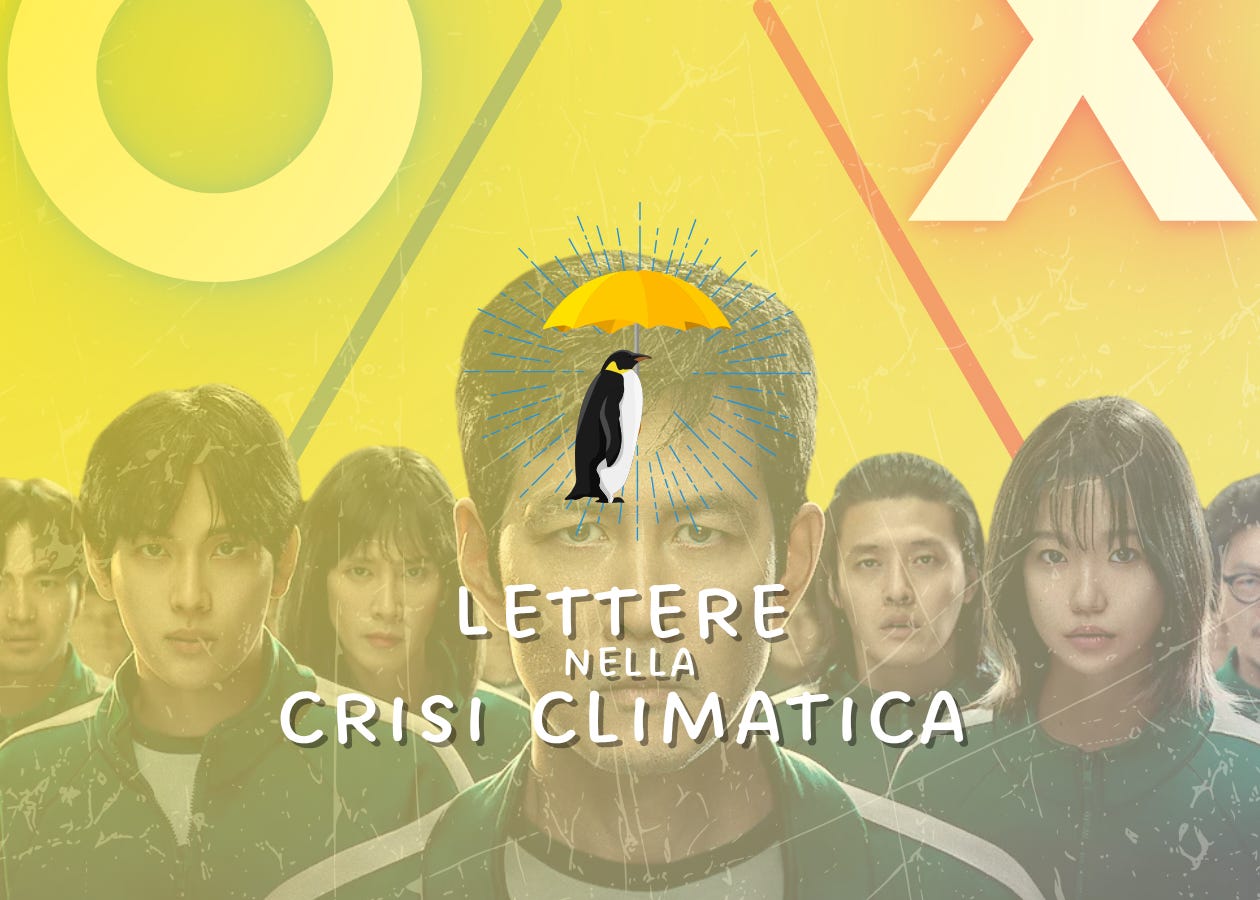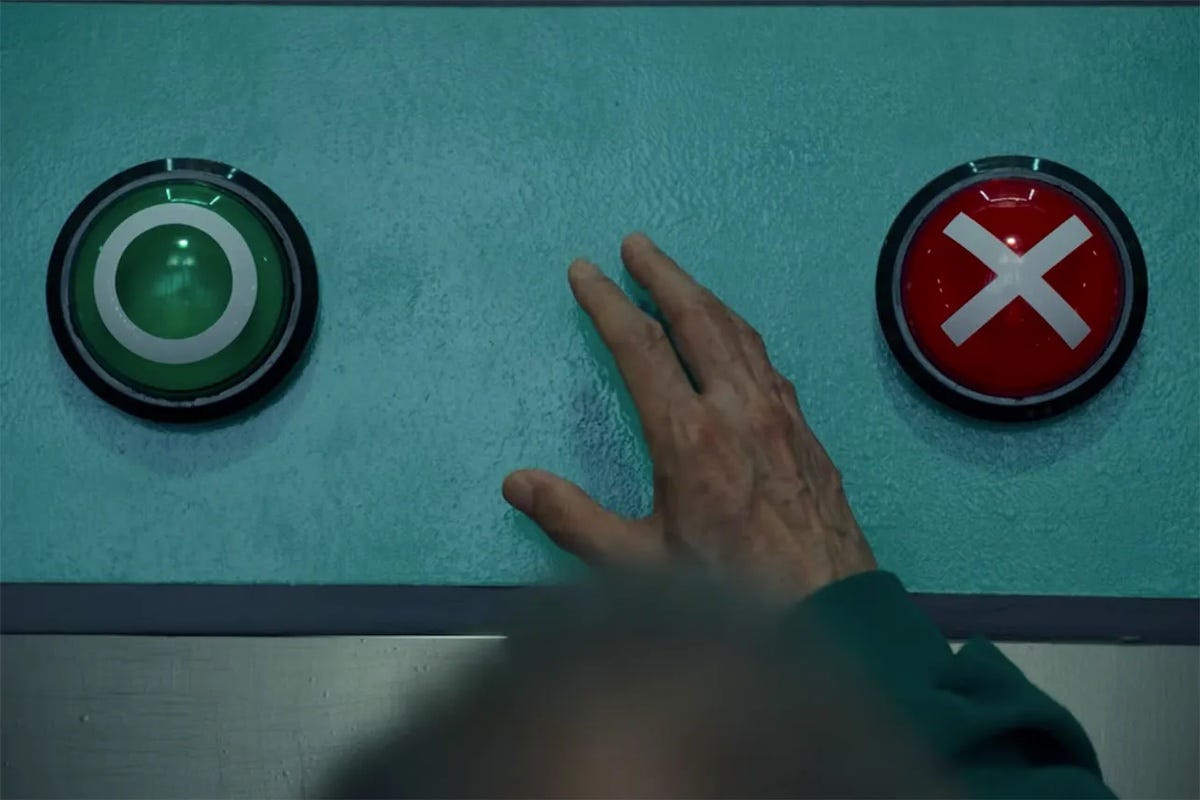Squid Game: lo specchio sulla nostra società
Serie Tv come Squid Game ci fanno riflettere sulle nostre democrazie grazie allo storytelling, ecco qui la mia recensione
Recentemente si è concluso Squid Game e, se mi segui, sai che nelle lettere mi piace parlare con te dello storytelling e della sua capacità di raccontare e cambiare il mondo.
Come sai, Squid Game è stato uno vero proprio fenomeno culturale che dalla Corea del Sud si è affermato a livello globale. Mi ricordo ancora di quando nel 2021, con le varie restrizioni COVID, mi sincronizzavo con la mia compagna distante oltre 600km per far partire contemporaneamente gli episodi in coreano con i sottotitoli in Italiano. La serie diretta da Hwang Dong-hyuk è diventata in diciassette giorni lo show Netflix più visto di sempre, tant’è che è stata tradotta in tempi relativamente brevi e da qualche anno ormai è tra gli ospiti fissi degli eventi del Lucca Comics & Games.
Ma Squid Game non è solo un'opera di finzione (come del resto tante altre serie Tv o videogiochi e fumetti), bensì attraverso il suo storytelling ci dà qualche elemento di riflessione sulle nostre democrazie, non solo quella della Corea del Sud. Per questo eccomi con una mia recensione di Squid Game dove ho cercato di non fare spoiler.
Cosa ci insegna Squid Game?
Squid Game è una serie sudcoreana scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk che racconta le storia di Seong Gi-hun, un ludopatico, divorziato ed enormemente indebitato che viene reclutato insieme ad altre 455 persone in dei giochi mortali per vincere 45 miliardi di won (circa 30 milioni di euro).
Gli Squid Game si tengono a cadenza ricorrente, sembrerebbe una volta l’anno, e si compone da sei sfide complessive, ognuna ispirata dai giochi dell’infanzia coreana, al termine delle quali viene eletto un unico vincitore.
Anche se sono uscite tre stagioni di Squid Game su Netflix, per me ha più senso dividerla in due parti, la prima coincidente con la stagione 1 che racconta la 33esima edizione del gioco e la seconda parte che si svolge tra la stagione 2 e 3 raccontando i 36esimi Squid Game. In questa recensione ho cercato di riportare quelle che sono per me le tre lezioni su cui possiamo riflettere anche guardando una serie tv di questo tipo:
le nostre società sono profondamente diseguali
il criterio della maggioranza non è per forza il migliore
siamo profondamente umani, nel bene o nel male
La prima lezione sta in cosa ha ispirato Squid Game: le profonde disuguaglianze nelle nostre società
La prima lezione è forse quella più basilare per cogliere il valore di Squid Game al di là del fenomeno pop. La serie Tv di Netflix è profondamente radicata nella storia, anche più buia, della Corea del Sud e nella lettura della società sudcoreana. Però sarebbe riduttivo circoscrivere il pensiero dietro a Squid Game a questo, anzi se allarghiamo lo sguardo la serie parla della società globale contemporanea in cui viviamo.
La storia della Brothers Home di Busan: Squid Game prima di Squid Game
Non è mai stato confermato dal regista ma Squid Game sembrerebbe prendere ispirazione dalla “Brothers Home” (Hyungje Bokjiwon) di Busan, una delle pagine più nere della storia sudcoreana raccontata nel 2020 alla BBC da Han Jong-sun.
Negli anni ‘80 il Paese si preparava ad ospitare i giochi asiatici del 1986 e le Olimpiadi di Seoul del 1988, così il governo di Chun Doo-Hwan (salito al potere nel 1981 con un colpo di stato militare) intraprese una serie di iniziative contro le persone senza dimora in nome del progresso del Paese. Vennero così finanziati dei centri di assistenza sociale, in gran parte privati ma sostenuti con sovvenzioni governative in base al numero di persone ospitate (più persone c’erano e più soldi venivano dati ai direttori della struttura). Queste strutture nate come orfanotrofi nel 1960 e poi convertite in centri assistenziali nel 1975 dall’allora dittatore Park Chung Hee (di cui Chun Doo-Hwan era un sostenitore), avevano lo scopo formale di rieducare e re-includere le persone senza dimora ma in realtà vi furono recluse persone con disabilità, avversari politici, prostitute, orfani e chiunque non poteva mostrare dei documenti d’identità grazie al supporto della polizia (che veniva ricompensata).
L’operazione di “pulizia sociale” di Chun Doo-Hwan negli anni ‘80 portò a una forte repressione delle fasce in una maggiore condizione di vulnerabilità tale che la Brothers Home di Busan, alla cui guida c’era Park In-geun (ex-militare e assistente sociale), arrivò ad recludere fino a 4.000 persone contemporaneamente nonostante la capienza massima fosse di 500. Si stima che su oltre 40.000 persone imprigionate negli anni di attività, meno del 10% fossero effettivamente delle persone senza dimora.
La Brothers Home di Busan era un campo di concentramento, successivamente è stata chiamata “l’Auschwitz coreana”, il cui principale scopo era quello di far arricchire il direttore del centro. Si stima che Park In-geun grazie alla Brothers Home di Busan mise un patrimonio equivalente a più di 90 milioni di euro di oggi e questo fu possibile anche alle scelte per risparmiare sui costi di gestione.
Questo ricorda un pò l’esperimento carcerario di Stanford svolto da Philip Zimbardo conosciuto come “effetto lucifero”: sostanzialmente Park In-geun per la Brothers Home decise di non assumere personale competente per gestire la struttura e promosse a guardie alcuni tra i prigionieri più violenti presenti nel centro. Presto questi detenuti crearono un’organizzazione a stampo para-militare per reprimere gli altri con bastonate, punizioni corporali, abusi e giochi violenti. Esatto, qui c’è il punto di contatto con Squid Game. Le guardie della Brothers Home di Busan per passare il tempo facevano fare agli altri detenuti dei giochi umiliandoli per intrattenersi.
Park In-geun venne arrestato nel 1987 per appropriazione indebita e confinamento illegale grazie alle proteste di alcuni parenti delle persone rinchiuse ma fu condannato solo per due anni e mezzo di carcere. Come ti dicevo c’erano molti interessi del governo e venne condannato “solo” per essersi appropriato dei sussidi governativi, non fu mai chiamato a rispondere delle violazioni dei diritti umani. Anzi lo stesso governo intimò alle vittime di tacere su quanto accaduto. Pensa che solo nel 2012 si iniziò a parlare nuovamente della vicenda e a studiare quanto accaduto.
La crisi della SsangYong Motor in Corea del Sud
Invece tra le vicende esplicitamente citate dal creatore di Squid Game c’è l’effetto della crisi economica sulla Corea del Sud, come ad esempio i licenziamenti di massa avvenuti nel 2009 alla SsangYong Motor (casa automobilistica sudcoreana conosciuta anche come KGM - KG Mobility Company).
Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 anche la casa automobilistica sudcoreana è stata infatti colpita dalla crisi finanziaria globale, da cui ancora oggi non si è ripresa. A causa di quegli eventi venne previsto un taglio occupazionale del 37%, oltre 2000 dipendenti furono licenziati, ed è stata messa in amministrazione controllata. Ci fu una dura lotta da parte dei lavoratori licenziati, che occuparono la fabbrica per 77 giorni nonostante la dura repressione della polizia, mentre però si contavano i suicidi e l’aumento dell’indebitamento tra le famiglie colpite. Nel 2010 le quote vennero rilevate dall’impresa indiana Mahindra & Mahindra che però nel 2020, quando deteneva oltre il 74,65%, ha tagliato i finanziamenti causando una nuova istanza di amministrazione controllata e fallimento.
In un'intervista con l’Associated Press, Hwang Dong-hyuk ha spiegato che attraverso i riferimenti ai licenziamenti di SsangYong, ho voluto mostrare come una persona comune, appartenente alla classe media, possa improvvisamente trovarsi a precipitare nel baratro economico. D’altronde sui muri della sala comune durante la 36esima edizione degli Squid Game è sempre presente la scritta “Hodie Mihi, cras tibi” che sta per “oggi sono io, domani sarai tu. Questa stessa espressione viene utilizzata da Gi-hun durante i giochi alludendo alla sfiducia e alle tattiche di sopravvivenza dei giocatori.
Le disuguaglianze strutturali come perno narrativo di Squid Game
La prima lezione di Squid Game ci insegna quindi che il nostro sistema globale è profondamente diseguale e che si “può toccare a tutti” ma non proprio a “tutti tutti”. Se ci pensi l’intero sistema degli Squid Game è tenuto in piedi dalle disuguaglianze strutturali delle nostre società che genera persone sfruttabili da oligarchie che lentamente hanno consolidato il proprio predominio.
Al di là della scrittura dei VIPs, che per me è uno dei tasti più dolorosi di tutto l’impianto narrativo di Squid Game, la storia si focalizza sulle azioni di persone messe al margine che si scontrano o si alleano mentre delle persone ricche li guardano distanti fisicamente, emotivamente e per stile di vita. Il gioco è stato ideato come fonte di divertimento per persone molto ricche (i VIPs) che assistono e scommettono su chi sopravvivrà alle prove e ai giochi, e come una possibilità per i concorrenti di fuggire alle proprie terribili situazioni finanziarie (che un pò sembra la caricatura del motivetto “se vuoi, puoi” o “se hai talento puoi alla povertà”). Il tutto mentre i giocatori sono tenuti costantemente sotto controllo da guardie mascherate armate e dal Front Man, che come una forza di polizia sovrintende e coordina l’intero gioco. Possiamo anche aggiungere che alla fine della serie sentiamo il Front Man dire “puoi anche uccidermi ma non farà la differenza, verrò semplicemente sostituito”. Lo stesso Front Man riconosce di essere un ingranaggio di un sistema ben radicato.
Se ci pensiamo la stessa crisi finanziaria si innesca negli USA a causa del crescente debito privato e la facilità con cui i mutui subprime venivano concessi. Secondo alcuni studiosi c’è anche una matrice psicologica dietro la crisi rinvenibile nella “bulimia dei consumi”, un fenomeno per cui i piccoli consumatori hanno speso ben oltre le proprie possibilità inseguendo un determinato stile di vita indebitandosi. Però la crisi economica, insieme alla pandemia e all’11 settembre, è stato uno degli shock che ci ha ricordato come siamo (ormai) irrimediabilmente interconnessi e che progressivamente reso sempre più nette le divisioni, ad esempio tra le classi sociali sopravvissute alla crisi e chi ne è stata profondamente colpita. Anche i fatti della SsangYong Motor ci raccontano di come la polizia è stata utilizzata per “pacificare” la situazione mantenendo le nette divisioni che si sono create.
Questa divisione di classi sociali però passa anche per la crisi climatica. Se da un lato è vero che è una crisi profondamente diseguale per cui ogni persona è colpita in modalità diverse secondo le proprie condizioni di vulnerabilità, dall’altra è anche vero che la crisi economica ha approfondito queste disuguaglianze causate dai cambiamenti climatici. Ad esempio con la crisi dei mutui subprime molti attori finanziari, come i fondi di investimento, hanno investito nei cosiddetti “beni-rifugio” come appezzamenti di terra, metalli preziosi o materie prime alimentari. La terra si è trasformata in un asset finanziario di sicuro rendimento, avviando un circolo vizioso per il quale molti terreni lasciati improduttivi determinarono un calo di produzione e un aumento dei prezzi dei beni alimentari che a loro volta incisero negativamente sulla capacità di approvvigionamento alimentare dei paesi più poveri. Il tutto aggravato dalle siccità e dall’espropriazione dei terreni, in particolare nei paesi del sud globale.
Insomma il nostro è un sistema strutturalmente diseguale che per sopravvivere genera nuove disuguaglianze. Se non vogliamo credere a uno scenario crudele come quello descritto in Squid Game sicuramente possiamo però dirci che qualcosa non sta funzionando. Secondo il report di Oxfam “Disuguaglianza, povertà ingiusta e ricchezza immeritata”, nel 2024 la ricchezza dei miliardari è cresciuta di 2.000 miliardi di dollari (a un ritmo tre volte superiori rispetto all’anno precedente) mentre il numero di persone che oggi vivono in povertà, ossia con meno di 6,85 dollari al giorno, è rimasto pressoché invariato dal 1990. In Italia la situazione non è migliore, il 5% più ricco delle famiglie italiane è titolare del 47,7% della ricchezza nazionale e possiede quasi il 20% in più della ricchezza complessivamente detenuta dal 90% più povero. L’Italia è un paese profondamente diseguale dove l’accumulazione della ricchezza è derivante da rendite di posizione (eredità, monopoli, clientelismo), da un sistema economico “estrattivo” o da politiche che vanno caratterizzandosi più per il riconoscimento e la premialità di contesti ed individui che sono già avvantaggiati. Come dire… non è una questione solamente degli Stati Uniti o della Corea del Sud… e se la scena finale di Squid Game non fosse solo un’anticipazione sul futuro della serie ma simboleggiasse il predominio di un’oligarchia miliardaria a livello globale?
La seconda lezione viene da Alexis de Tocqueville: Squid Game e la dittatura della maggioranza
La seconda lezione di Squid Game è stata più evidente durante la seconda stagione quando Gi-hun prende parte ai giochi con lo scopo di provare a fermare il sistema che li sostiene dall’interno.
Un aspetto fondamentale della serie è che le e i partecipanti sono accomunati dal fatto di non avere alternative a causa dei debiti, non importa il motivo ma questa è la caratteristica essenziale. Sia che siano stati truffati, licenziati per la crisi dell’impresa o per le proprie attività illecite, ogni concorrente di Squid Game deve guadagnare velocemente dei soldi per ripagare dei grossi debiti o per avere una vita significativamente diversa al di fuori dell’arena.
Il funzionamento degli Squid Game è molto semplice: alla morte di ogni partecipante aumenta il montepremi che verrà diviso tra le persone che rimangono in vita al termine del gioco, ossia all’unico vincitore, o invocando la clausola n. 3. Infatti le e i partecipanti per iniziare il gioco hanno firmato un accordo costituito da tre clausole:
Non puoi lasciare il gioco
Se ti rifiuti di giocare, vieni eliminato
I giochi si possono fermare solo con un voto a maggioranza
Insomma di fronte al rischio per la propria vita basta che 229 giocatori su 456 votino a favore della sospensione dei giochi. Semplice, no?
Bene il meccanismo del voto è centrale per tutta la seconda stagione e dopo ogni round mortale vediamo i partecipanti parlare in pubblico per convincere gli altri a votare per proseguire o fermare i giochi, contare i voti mancanti o intimidire i partecipanti prima del voto. L’atto del votare diventa così importante che gli organizzatori “vietano atti di disturbo di qualsiasi tipo per lo svolgimento democratico”. Più volte durante la seconda parte di Squid Game (stagione 2 e 3) sentiamo gli organizzatori ripetere agli altoparlanti che si tratta di scelte prese in modo democratico e che verranno represse con la violenza tutte le azioni contrarie a questa scelta.
In questo processo democratico i giocatori si trovano davanti a questa domanda “continuo a giocare per ripagare i miei debiti o ci fermiamo per salvare più vite possibili?”. Squid Game enfatizza il problema se come società ci soffermiamo solo sull’aspetto formale della democrazia: anche se la scelta può essere moralmente sbagliata e profondamente rischiosa per la vita, la maggioranza dei voti prevale e decide il destino della collettività. Attraverso litigi, coercizioni o corruzioni i personaggi scelgono quale opzioni votare e, anche se per pochi voti e nonostante le morti, la risposta che prevale è quella di “fare solo un ultimo gioco”: chi per ripagare tutti i debiti o chi per uscire da una vita sempre più dura, i partecipanti fanno una valutazione personale dei possibili rischi e benefici orientata al breve termine, sulla base delle emozioni e delle riflessioni sul momento.
Alexis de Tocqueville e la dittatura della maggioranza
Squid Game sembra proporre la sua personale interpretazione della “dittatura della maggioranza” mostrata da Alexis de Tocqueville in “La democrazia in America”.
C’è da dire che Tocqueville si inserisce in una riflessione politica che sta ancora facendo i conti con le democrazie moderne. Per capirci meglio basta pensare che il suo maestro Benjamin Constant credeva che occorreva limitare il diritto di voto ai soli proprietari, mentre tanti altri volevano introdurre delle condizioni (ad esempio reddituali) al diritto di voto. Tocqueville è tra i primi pensatori che prende atto del suffragio universale e leggendo la società dell’800 afferma che questo assegna realmente il governo della società alle classi meno abbienti, essendo la maggioranza della popolazione.
Se a questo proposito si è potuto parlare di una esagerata sopravvalutazione della sovranità popolare, dettato dal timore e dalla diffidenza piuttosto che da un'analisi della realtà, l’aspetto fondamentale che avanza Tocqueville è quello dell’eguaglianza delle condizioni nella mentalità democratica: il non riconoscere alcuna superiorità di rango o di altro genere, e il collocare gli individui su un medesimo terreno. Sotto questa chiave di lettura, ripresa anche nel’900 con un'analisi della “massa” come fattore patogeno delle democrazia, arriva ad affermare il concetto di onnipotenza o dittatura della maggioranza osservando come la “maggioranza” negli Stati Uniti si esprime negli spazi sempre più grandi che vengono occupati dal potere legislativo, esercitato da deputati fortemente condizionati dall’opinione popolare, dall’esecutivo o dal giudiziario.
Non dobbiamo dimenticare che Tocqueville è un pensatore liberale che si interroga sulla questione sociale sollevata proprio dai socialisti del suo tempo e che vede l’essere umano guidato solo dall’utile (razionalità strategica). Insomma non è “un fan della massa”, il problema per Tocqueville è che cosa emerge a livello politico se la maggior parte delle persone sono in condizione di povertà?
Con il concetto di dittatura della maggioranza Tocqueville ci mette in allerta sul fatto che l’individuo non dispone di vere garanzie qualora i suoi diritti vengano violati col beneplacito della maggioranza del popolo. In altre parole ritiene che lasciata a sé stessa la maggioranza della popolazione "deciderebbe" per l'insieme degli individui, non tenendo in considerazione ad esempio la visione espressa dalle minoranze. Anzi aggiunge che in America, la maggioranza traccia un cerchio intorno al pensiero e fa l’esempio dello scrittore. Nell'interno di quei limiti lo scrittore è libero, ma guai a lui se osa oltrepassare perché la maggioranza vive in una perenne adorazione di sé medesima.
La dittatura della maggioranza nel 21° secolo
Tocqueville lo definirei quasi un nostalgico dell’aristocrazia ma la sua analisi delle “patologie della democrazia” non sono tanto distanti da quelle che hanno teorizzato altri autori, un discorso molto simile lo fa Polibio nel II secolo a.C. Ovviamente molte cose sono cambiate dall’800 però si può dire che Tocqueville non teneva conto di come le disuguaglianze possano influenzare il meccanismo democratico, ad esempio in molti e molte non hanno tutt’oggi accesso al voto o non riescono ad andare a votare e per questo si pensa di approfondire il nostro metodo di governo attraverso la democrazia deliberativa e partecipativa.
Squid Game ci presenta una “tirannia della maggioranza” in cui le decisioni favoriscono una parte a discapito di chi è debole e ricattabile. Non ci sono vie di mezzo ma una competizione tra chi vuole giocare fino a che non raggiunge la cifra desiderata e chi vuole smettere per porre fine a questa follia (magari perché ha già la somma di cui ha bisogno). Se è vero che “la maggioranza traccia un cerchio intorno al pensiero” per cui non sei libero di pensare oltre a quel cerchio cosa accade se la maggioranza ritiene giusto pensare a se stessi, arricchirsi senza pensare agli effetti sulle vite degli altri o delle generazioni future, che una questione non sia prioritaria rispetto ad un altra e che la discriminazione tutto sommato sia giusta?
Negli Squid Game una riflessione complessa viene semplificata sostanzialmente in una scommessa sulla speranza di un beneficio a breve. La promessa di ottenere più soldi alla fine del gioco diventa una sorta di potere invisibile che spinge molti giocatori a votare di continuare i giochi a discapito nella prospettiva futura di poter effettivamente vivere al di fuori delle mura dell’arena. Allo stesso modo Thanos e Gi-Hun esercitano un potere ben visibile per influenzare le scelte degli altri, il primo per continuare i giochi e il secondo per portare avanti la sua rivoluzione, mentre il Front Man tiene sotto controllo la situazione con piccole e impercettibili mosse. Ciò restituisce una dinamica ancora più complessa sul funzionamento delle nostre democrazie in cui ci sono giochi di potere, più o meno visibili, che si scontrano e confrontano a diversi livelli.
La terza lezione: “siamo profondamente umani”
La terza lezione di Squid Game l’ho trovata nelle parole che ricorrono soprattutto nella terza stagione e che vengono pronunciate da Gi-hun: “noi non siamo cavalli, siamo esseri umani, gli esseri umani sono…”.
Bene, con questa frase Squid Game cerca di mettere un punto sulla visione della stessa serie come un caleidoscopio delle personalità dell’umano. Ogni personaggio è caratterizzato per rappresentare una caratteristica peculiare come può essere l’indipendenza, la resilienza, il coraggio, l’altruismo, l’egoismo, la determinazione, la vulnerabilità, il narcisismo, la codardia, la timidezza, l’intelligenza, la gentilezza, il sadismo, oppure l’essere amorali, premurosi, protettivi, sadici e doppiogiochisti.
C’è un grosso spaccato delle nostre società nelle tre stagioni di Squid Game e vediamo persone come Ali Abdul, migrante pakistano che vuole dare un futuro alla sua famiglia, Kang Sae-byeok, borseggiatrice che fuggita dalla Corea del Nord vuole mantenere il fratello e far fuggire la madre, e Hyun-ju, donna transgender che ha bisogno dei soldi per gli interventi e una nuova vita. Ma ci sono anche persone disposte a tutto come Jang Deok-su, gangster molto aggressivo, e Thanos, un rapper in rovina che fa di tutto per far continuare i giochi.
Però abbiamo anche il nostro protagonista Gi-hun che queste caratteristiche le racchiude tutte e che le prova nel corso delle tre stagioni. Se nelle prime due vediamo il suo lato più positivo, soprattutto nell’ultima vediamo il suo lato più brutale. Non è un caso, Gi-hun è il simbolo di cosa significa essere umani, è ciò che completa quella frase che rimane in sospeso.
Questo assume un significato ancora più profondo se si ricollega questa frase con quanto dice il Front Man nella prima stagione parlando dei giocatori, ossia “Voi siete tutti cavalli in un ippodromo”. Una visione che vede i partecipanti, così come lui stesso, come parte di un sistema già scritto, che si ripete circolarmente e vede i corridori destinati alla morte se non vincono. Ebbene se la Sciamana a un certo punto della storia dice a Gi-hun “c’è una ragione per cui sei stato portato in questo luogo” è perché durante gli Squid Game il nostro protagonista dimostra che “essere umani” significa essere tutte quelle cose ma che, pur in un sistema profondamente diseguale e che continua indisturbato, possiamo sempre fare (o non fare) la scelta per decidere da che parte stare.
Il futuro di Squid Game e alcune riflessioni conclusive
Squid Game non è una serie “perfetta”. Qua e là ci sono delle sbavature, dei buchi di trama o delle scelte narrative che rischiano di sembrare delle forzature (per me, ad esempio, lo è stata quella della neonata anche se poi si è rilevata funzionale alla trama generale).
La serie Netflix, inoltre, è permeata da strutture, schemi ed elementi provenienti dal mainstream ed è questo il punto di forza (per la sua diffusione) e di debolezza (per la sua innovatività). Ci sono continue citazioni tematiche e visive come la scala pastellata che mischia Escher e l’estetica dei giochi anni ‘90, le tute dei sorveglianti che assomigliano fin troppo a quelle dei protagonisti di La casa di carta, la gigante stanze dei giochi con pareti pitturate da sfondamenti illusionistici che richiamano The Truman Show, oppure la scelta tra rosso o blu che potrebbe richiamare gli stessi colori delle pillole di Matrix).
Insomma Squid Game è un prodotto della cultura pop che vuole arrivare al grande pubblico e come tale soffre dei limiti di questa operazione. Pur rientrando nel topos della narrazione di divario sociale, molto sentita nella Corea del Sud e che abbiamo visto in opere come Parasite, alla fine la serie sembra piegarsi alle necessità (o volontà) di commercializzazione.
Sia chiaro, Squid Game ha uno storytelling solido nel suo complesso ma penso anche che la prima stagione abbia giovato molto della curiosità e interesse che si è generato con la “Korean wave” da cui siamo stati investiti, per cui tutti (anche io) ci siamo accorti del panorama narrativo di questo paese. La seconda parte però sembra fare più fatica e ho avuto l’impressione che il regista dovesse lottare contro la sensazione del “già visto” che potrebbe avere lo spettatore. Una sfida che per me è in parte riuscita, per me il valore della serie è nelle “tre lezioni” che, oltre a Gi-hun, ci dona una serie di personaggi caratteristici tra cui Hyun-ju, una donna transgender che ha una storia solida all’interno della serie e che ho sinceramente apprezzato (alla faccia di tutti quelli che hanno paura della diversity e del woke!).
Noterai forse che ci sto girando intorno ma eccomi qua: quello che mi preoccupa è proprio il futuro di questa serie.
Penso che ogni prodotto debba essere pensato con un inizio e una fine in modo da strutturare uno storytelling coerente e veramente avvincente. Non sono un fan di quelle serie che vengono tirate a lungo senza senso (se non solo quello di guadagnarci su). Per questo se effettivamente decidessero di portare gli Squid Game negli Stati uniti spero che riescano a inventare qualcosa di innovativo e che non proponga sostanzialmente “uno Squid Game con dei cosplayer americani”.
Ma poi avrebbe senso una serie che porta in scena degli americani che si comportano da sudcoreani o che fanno giochi tipici dell’infanzia della Corea del Sud? Lo sapremo solo in futuro ma nel frattempo voglio sapere cosa ne pensi!
Squid Game non è solo una Serie TV e come tutte, almeno in parte, offre uno specchio sulla nostra società. E tu, cosa ne pensi? C’è qualche aspetto che ti ha colpito della serie o qualcosa che ti ha fatto proprio storcere il naso? Oppure vorresti una nuova lettera di questo tipo ma su un videogame, un fumetto o un’altra serie tv? Segnalamelo nei commenti e cercherò di fare del mio meglio :)
Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica👇