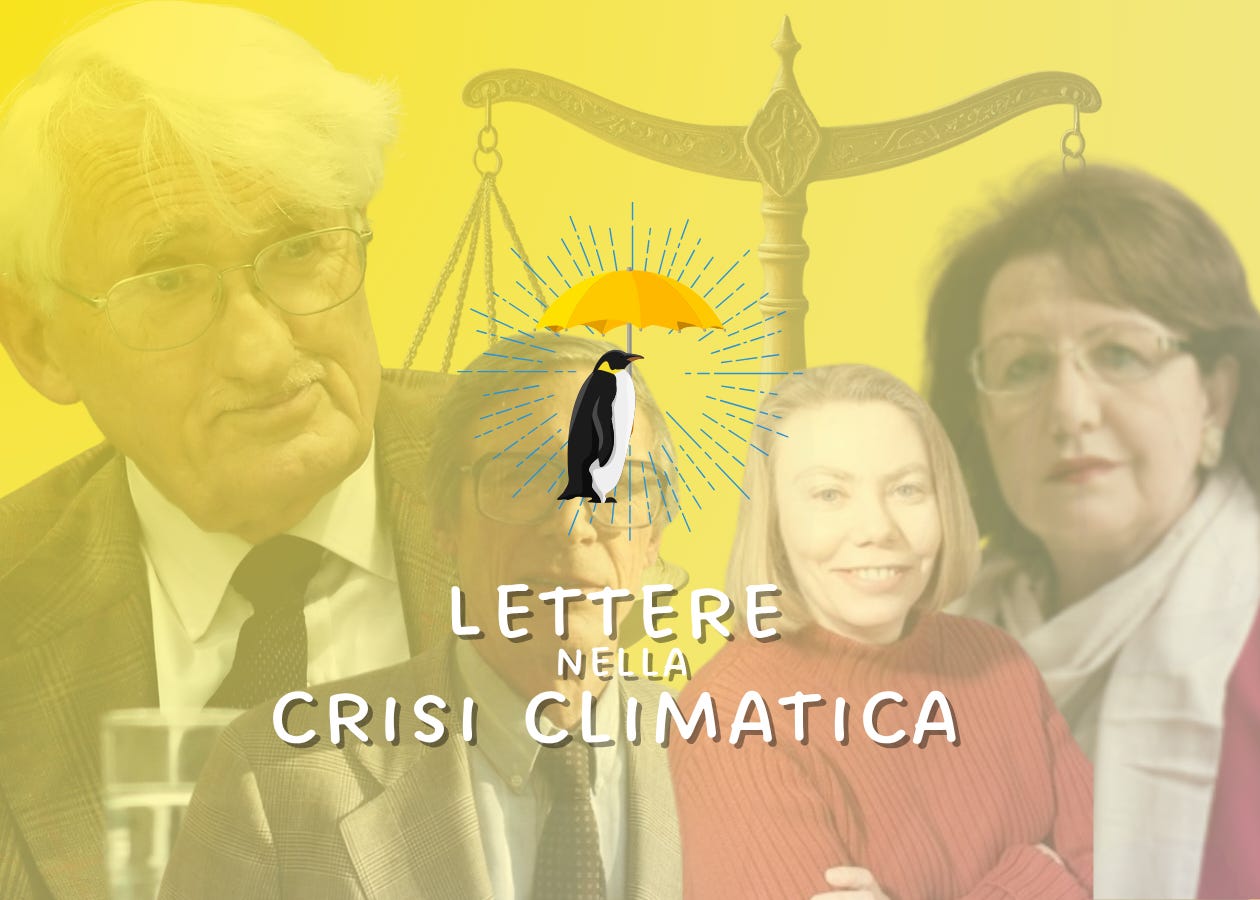Democrazia deliberativa: anatomia di un concetto
La democrazia deliberativa si muove tra teoria e prassi di governo che generano istituti di innovazione democratica, ecco perché è importante per la crisi climatica
Viviamo sicuramente in tempi difficili e la crisi della democrazia, almeno nella sua accezione rappresentativa, chiede di approfondire il modo in cui ci governiamo con metodi della democrazia deliberativa e partecipativa in grado di affrontare la crisi climatica.
Ma cosa è la democrazia deliberativa? Quando parliamo di “metodi” della democrazia deliberativa intendiamo un insieme organico di regole e principi che facilitano la partecipazione delle persone in un ruolo attivo di costruzione di decisioni di rilevanza pubblica e che si basa su un confronto argomentato tra opinioni.
Sostanzialmente si tratta di metodi che si riferiscono ai principi della democrazia deliberativa, secondo cui i processi di coinvolgimento delle persone su decisioni pubbliche devono essere:
costituiti da “mini-pubblici”, ossia gruppi di cittadini e cittadine che riflettono la diversità sociale del contesto di riferimento (quartiere, città, regione, nazione…)
dialogici (dal greco “discorso tra persone”), mirano a creare una comunicazione interpersonale empatica e quindi tendente al “bene comune”
informati, durante il processo si ascoltano diversi punti di vista per arrivare a opinioni ben fondate e bilanciate
deliberativi (dal latino “libra”, bilancia), nel senso che si valutano i pro e i contro dell’oggetto discusso oltre che le loro implicazioni
in grado di creare consenso, si va oltre il criterio della maggioranza semplice e le proposte vengono approvate all’unanimità o con la maggioranza qualificata
influenti, almeno una quota del potere decisionale viene restituita alle e ai partecipanti
Come vedi i metodi della democrazia deliberativa, rispetto a quelli della democrazia partecipativa, fanno riferimento a un impianto fortemente filosofico e prescrittivo che spesso ha fatto sorgere dei dubbi sulla reale applicazione. Per questo è fondamentale osservare e analizzare i casi pratici che sperimentano l’applicazione dei principi teorizzati. Le pratiche di democrazia deliberativa in Italia attualmente sono numericamente inferiori rispetto a quelle partecipative ma si sta osservando un aumento di pratiche relative alle assemblee deliberative (o assemblee dei cittadini) sui cambiamenti climatici.
Una piccola ricostruzione della teoria della democrazia deliberativa
La democrazia deliberativa è frutto di un complesso e ampio dibattito che ha visto numerosi studiosi provenienti dalle più diverse discipline (dalla filosofia, alla sociologia, fino ad arrivare ai giuristi e agli scienziati politici). Per questo ricostruire precisamente il discorso sulla democrazia deliberativa non è facile, vuoi per la sua varietà o contraddizioni interne.
In questa lettera però vorrei restituire qualche aspetto chiave della teoria della democrazia deliberativa e alcune delle persone protagoniste di questo dibattito (cosi per farci qualche idea sui possibili punti di forza e punti di debolezza). Prima però torniamo un pochino indietro nel tempo.
L’ideale della democrazia ateniese come fonte d’ispirazione
La teoria della democrazia deliberativa ritorna un pò alle origini della politica per recuperare il mito della “polis” e della democrazia ateniese. Nell’ideale della democrazia ateniese infatti l’agorà, la piazza principale della città dove potevano accedere tutti, era il simbolo della discussione politica nello spazio pubblico.
In questo spazio, fisico e politico, sono iniziate quelle pratiche che hanno successivamente caratterizzato la società occidentale come il discorso argomentativo, la filosofia e il dibattito politico.
Nella democrazia ateniese il comando non è proprietà esclusiva di qualcuno ma è il risultato di un confronto dialettico, un processo comunicativo attraverso il quale si esamina una questione e se ne pesano con attenzione i vantaggi e gli svantaggi.
Per il resto quando si parla del modello della democrazia ateniese si fa riferimento a quelle istituzioni politiche definite da Clistene e riformate da Pericle, ossia:
l’Ecclesia, l’assemblea dei cittadini di pieno diritto ossia l’istituzione che incarna la sovranità politica e che era aperta a tutti i cittadini maschi e liberi che abbiano più di 18 anni. Tutti avevano il diritto di parola e le decisioni venivano prese a maggioranza su questioni legislative e di governo.
la Boulè, che scriveva le leggi e aveva un carattere più amministrativo. Di questa istituzione faceva parte una quota più limitata della cittadinanza attraverso il consiglio dei 500
Idealmente prima di prendere una decisione la città doveva aver esaminato gli argomenti favorevoli e contrari su quella questione. Nella democrazia ateniese stessa discussione e riflessione venivano considerate un momento essenziale nella vita di ogni cittadino, in quanto realizzano l’ideale della partecipazione diretta al governo e, tramite essa, dell’uguaglianza.
Qui il “disclaimer” da fare è che per i greci non tutti erano “cittadini” e, di conseguenza, non tutti avevano i diritti riconosciuti al cittadino.
Si faceva una distinzione tra la polis, dove si incontrano gli “uomini liberi” che si riconoscono tra eguali, e l’oikos, dove viene collocata la donna e gli affari (l’economia) ma anche dove si celebra la vita privata. La caratteristica principale della democrazia ateniese è che, essendo eguali e liberi, le cariche politiche principali venivano attribuite per sorteggio tra i membri dell’Ecclesia.
Il principio della deliberazione pubblica intesa nelle modalità della democrazia ateniese è stata ripresa da diversi autori nei secoli successivi.
Ad esempio Jean-Jacques Rousseau afferma che la “volontà generale” essendo rivolta all’interesse comune non può coincidere con la somma delle volontà particolari fino al raggiungimento della maggioranza, bensì è il risultato di una deliberazione svolta nelle giuste condizioni.
John Stuart Mill invece considera la partecipazione alla deliberazione pubblica come un mezzo essenziale di accrescimento e di crescita morale che è funzionale alla creazione di una cittadinanza informata, virtuosa e impegnata. Con l’affermazione della democrazia di massa e del principio della rappresentanza queste “anticipazioni” della democrazia deliberativa passano in secondo piano fino al rinnovato interesse degli studiosi che durante la seconda metà del ‘900 iniziano a interrogarsi sulla crisi della democrazia e sul come rivitalizzarla. Primo tra tutti, ovviamente, Habermas.
Jürgen Habermas, il riferimento della democrazia deliberativa
Jürgen Habermas, oltre a essere tra i principali esponenti della Scuola di Francoforte (culla della teoria critica), è il principale riferimento della democrazia deliberativa proprio perché al centro del suo pensiero risiede la possibilità di realizzare una politica e una società basate su un consenso reale (e non sul compromesso) costruito attraverso il dialogo.
Per Habermas il consenso è infatti un processo dialogico, in particolare viene visto come un accordo ottenuto secondo i procedimenti dell’argomentazione razionale intorno a un interesse comune che non è legato alla particolarità degli interessi privati.
Habermas ritiene che “l’essere pubblico” risale fin dalla democrazia ateniese, dove vi era una netta distinzione tra spazio pubblico e spazio privato che gradualmente si sfuma fino a sovrapporsi nel 17° secolo con l’avvento della società borghese e della società civile.
In questo modo l’informazione appartiene alla sfera pubblica ma diventa fondamentale anche per la gestione della sfera privata. Questi due spazi si fondono tra loro e in una prima fase nasce un opinione pubblica critica che dà il potere ai “sudditi” di diventare giudici dell’operato del sovrano.
Col tempo però si passa da un soggetto borghese critico a un soggetto consumatore di cultura, facendo sì che i mass media e i proprietari privati fossero capaci di influenzare l’opinione pubblica fino a renderla priva di capacità critica e di sostenere un dibattito critico sull’esercizio del potere.
Su queste basi Habermas costruisce la teoria dell’agire comunicativo secondo cui, molto brevemente, due soggetti capaci di interazione e linguaggio possono stabilire una relazione interpersonale per coordinare il proprio agire. L’agire sociale, cosi pensato, presuppone quindi un intesa comunicativa che viene costruita dai partecipanti attraverso il dialogo e che dipende dalla validità che gli interlocutori associano agli enunciati di ogni soggetto.
Durante gli anni ‘80 Habermas osserva le democrazie e afferma che queste si basano su un consenso costruito con il calcolo economico degli interessi. Questo non è un consenso reale perché secondo Habermas, in caso di contrasto tra interesse individuale e interesse collettivo, l’individuo non ha ragioni per vincolarsi alle regole della democrazia.
Di conseguenza occorre andare oltre il momento elettorale e favorire la democrazia deliberativa, la quale si basa sulla creazione condivisa di un sostrato valoriale creato attraverso il dialogo. Come esplorato anche nell’etica del discorso, Habermas vuole recuperare l’imperativo categorico Kantiano (un dovere incondizionato e universale che guida l'azione morale dell’individuo) per trasportarlo nella dinamica dialogica e relazionale, quindi in una dimensione sociale e non individuale.
Secondo Habermas la democrazia deliberativa dovrebbe creare uno spazio pubblico adatto all’espressione della libertà degli individui e della loro diversità di interessi privati, tutto questo in modo conforme a norme e procedure che portino a un consenso razionale di tutti i suoi partecipanti, ritenuti uguali in diritto e capaci di autonomia.
Per realizzare questa che è una situazione “ideale” si rende quindi necessario un network capace di comunicare informazioni e punti di vista, ossia uno spazio di discussione pubblica, distinto dallo stato e dal mercato”.
Habermas ritiene che la deliberazione pubblica abbia una dimensione cognitiva che è connessa alla ricerca del modo migliore di dare risposta alle questioni pubbliche, modo che trova attuazione nel confronto discorsivo di argomenti plurali, il quale dà luogo a un accordo razionalmente motivato.
Tuttavia la teoria habermasiana non è priva di critiche: se è vero che molti autori e molte autrici riconoscono il valore della teoria della democrazia deliberativa cosi come pensata da Jürgen Habermas, è anche vero che non tutti firmerebbero col sangue le sue premesse sociologiche e filosofiche.
Gran parte della critica ad Habermas riconosce la sua volontà di trovare un modello concettuale più adeguato alle società complesse del nuovo millennio, tuttavia occorre prendere più sul serio i presupposti sostanziali che sono alla base di forme di “democrazia procedurale”.
A questo proposito l'autonomia dei cittadini e delle cittadine deve essere protetta e ampliata attraverso la garanzia di determinati diritti sociali ed economici che consentano la partecipazione ai processi deliberativi democratici, altrimenti si continuerebbero a riprodurre disuguaglianze che sono di fatto “strutturali” (sopratutto nella società nella crisi climatica). Per questo ho pensato di riportare il contributo teorico al dibattito della democrazia deliberativa di personalità come John Rawls, Jon Elster, Seyla Benhabib e Amartya Sen.
John Rawls e il dialogo sulla democrazia deliberativa con Habermas
Nel marzo 1995 il Journal of Philosophy ospitò uno dei dialoghi filosofici più famosi, quello tra John Rawls e Jürgen Habermas. Il dialogo è sostanzialmente composto da un saggio critico di Habermas dal titolo “Riconciliazione tramite l’uso pubblico della ragione: considerazioni sul liberalismo politico di John Rawls”, dove si concentra sulla teoria della giustizia di quest’ultimo, e da uno scritto di Rawls che si intitola semplicemente “Risposta a Habermas”.
Il dialogo, portando all’attenzione di molti la democrazia deliberativa, ruota intorno al tentativo di trovare un fondamento stabile nel tempo di una struttura di base istituzionale in un contesto politico caratterizzato dal pluralismo delle idee, dall’esistenza di visioni del mondo ragionevoli ma che comunque sono in radicale contrasto e incompatibili tra loro.
Sia Habermas che Rawls intendono superare il modello secondo cui la società (liberale) si basa sulla possibilità di trovare compromessi temporanei su singole questioni.
Entrambi hanno in mente un modello di democrazia deliberativa ma lo vedono da due prospettive differenti. Come ti dicevo per Habermas la democrazia deliberativa è principalmente il processo di formazione del consenso e della volontà collettiva dei cittadini e delle cittadine attraverso il dialogo. È il processo deliberativo in se che genera consenso perché con la deliberazione (potremmo dire “il soppesare” le diverse posizioni) le persone maturano la convinzione della correttezza e dell’appropriatezza di certi principi rispetto ad altri.
John Rawls invece presenta un modello di democrazia deliberativa più come un modello di “democrazia costituzionale”, un modello ben ordinato che riguarda il funzionamento della struttura di base e le istituzioni fondamentali di una società.
Su questa base Rawls afferma la necessità della democrazia deliberativa perché in mancanza di un pubblico informato sui problemi più urgenti, prendere decisioni
politiche e sociali importanti è semplicemente impossibile.
Per questo si augura che le discussioni pubbliche che coinvolgono i cittadini siano rese possibili dalle istituzioni e riconosciute come una caratteristica di base delle democrazie anche prevedendo dei vincoli stringenti rispetto a ciò di cui si può dibattere o ciò che deve rimanere escluso dalla discussione politica.
Ad esempio John Rawls pensa che in una società liberale le diverse concezioni del mondo che si fondano su pretese di verità assolute, religiose o laiche, devono essere tenute fuori dall’arena pubblica secondo una logica di “evitamento” (avoidance).
Se da una parte riconosce che tutti hanno il diritto di sposare queste visioni secondo la libertà di coscienza e manifestazione del pensiero, dall’altra ritiene che le ragioni che hanno origine da queste visioni devono essere tenute fuori dalle istituzioni dove vengono prese decisioni che diventano vincolanti per tutti.
A ciò Rawls aggiunge che l’ideale di cittadinanza impone un dovere morale (di civiltà, non legale) di essere in grado di spiegarsi reciprocamente su questioni fondamentali come i principi e le politiche che sosteniamo e votiamo possano essere supportati dai valori politici della ragione pubblica. L’unione del dovere di civiltà con i grandi valori della politica produce l’ideale dei cittadini che si governano in modi che ciascuno pensa che gli altri possano ragionevolmente accettare.
L’impostazione della democrazia deliberativa di John Rawls si fonda su una netta separazione tra la “sfera privata valoriale” e lo spazio del “politico”, che diventa il regno di decisioni impersonali.
La logica di “evitamento” e il “dovere di civiltà” per Rawls diventano così la base del “consenso per intersezione”, uno spazio dove è possibile trovare un “minimo comun denominatore valoriale” e di principi condivisi su cui fondare le istituzioni.
Si tratta di principi comuni che sono rispettati e ritenuti giusti da tutti ma per ragioni diversi che ognuno ritrova nella propria personale visione del mondo. Così si genera un consenso intorno a una teoria della giustizia fatta di principi che non possono essere considerati “veri” in assoluto ma comunque “ragionevoli” per tutti, ritenuti compatibili e accettabili da differenti visioni del mondo.
Jon Elster sulla democrazia deliberativa
Jon Elster, filosofo e teorico politico norvegese, nel libro “Deliberative Democracy” (1998) ritiene che Habermas abbia avuto il merito di rilanciare l’ideale della democrazia deliberativa affermando che una democrazia può ruotare intorno alla “trasformazione” delle preferenze invece che a una loro semplice aggregazione fatta con il voto.
Al di là del voto, Elster nota che i gruppi sociali possono utilizzare la discussione e la negoziazione (o una combinazione di tutte e tre) per prendere una decisione su un qualcosa che li riguarda tutti ma su cui la distribuzione iniziale delle opinioni non raggiunge il consenso.
Elster ritiene, inoltre, che in un processo decisionale collettivo le preferenze degli individui possono essere soggette ad aggregazione, trasformazione o una rappresentazione errata. Se nel primo caso ci riferiamo al voto e allo scambio del voto, la trasformazione delle preferenze attraverso la deliberazione razionale è l'obiettivo della democrazia deliberativa.
Il problema è che in tutti i casi ci si può scontrare con una rappresentazione errata delle preferenze perché, ad esempio, il voto può essere strategico o perché il risultato della deliberazione può essere influenzato da una sorta di “processo di contrattazione” determinato anche dal potere delle parti che contrattano attraverso minacce, promesse credibili o discorsi convincenti.
Questo problema se lo era già posto Rousseau molto tempo prima e secondo il filosofo ginevrino per avere un “voto puro” i cittadini dovevano formare le loro preferenze in modo isolato gli uni dagli altri, in modo da non essere contaminati dall'eloquenza e dal populismo. Va da sé che, ancor più oggi, l’ideale secondo cui dobbiamo formarci un idea in un “ambiente sterile” è irrealizzabile (non so neanche quanto sia desiderabile in realtà).
Jon Elster parlando della democrazia deliberativa fa un paragone tra il dibattito scientifico e la deliberazione politica che possiamo riassumere così:
il dibattito scientifico si concentra su un fatto oggettivo che può essere compreso correttamente
il dibattito politico, nella misura in cui il dibattito riguarda lo scopo ultimo della società, non può avere una pretesa di oggettività
Io non sono un ingegnere, sono un umile (spero) scienziato politico, ma Elster ritiene che un’analogia migliore per comprendere il dibattito politico è quella dell’ingegneria: l’obiettivo della democrazia deliberativa sarebbe quello di trovare un’approssimazione che funzioni per tutte le parti coinvolte piuttosto che la verità.
Questo è dovuto anche al fatto che nella vita politica occorre prendere una decisione che spesso ha vincoli temporali e che deve fare i conti con le motivazioni di chi partecipa al dialogo deliberativo. Jon Elster a proposito distingue tra ragione, interesse e passione.
La ragione è imparziale, disinteressata e spassionata per questo nel dialogo ognuno dovrebbe fare appello a valori imparziali o comuni. Eppure il rischio è che i soggetti che dialogano nell’arena deliberativa siano presi dai propri interessi, obiettivi o emozioni del momento (insomma magari usi molto l’auto e ti sentiresti contrariato nell’eliminazione dei parcheggi per fare spazio alle piste ciclabili!).
Elster sottolinea che la composizione dei soggetti che partecipano a uno dei metodi della democrazia deliberativa è cruciale. La selezione dei rappresentanti può essere distorta da pregiudizi e squilibri strutturali, come dimostrato dall’esempio dell’Assemblea costituente di Francoforte del 1848: nonostante il suffragio universale maschile, ne furono esclusi contadini, operai e classi popolari.
Infine secondo Elster la “rappresentanza” e la “deliberazione” sono due obiettivi in tensione tra loro, non è scontato infatti che ottimizzare la rappresentanza significhi migliorare anche la deliberazione, o viceversa.
Ad esempio l’istruzione potrebbe migliorare la qualità deliberativa ma questa ancora oggi non è equamente accessibile. Inoltre la rappresentanza delle opinioni può sembrare più importante di quella degli individui, ma questo presuppone una omogeneità interna dei gruppi, che nella realtà non esiste.
La riflessione di Seyla Benhabib sulla democrazia deliberativa e il problema della differenza
Seyla Benhabib attraverso il libro “Democracy and difference, contesting the boundaries of the political” (1996), una curatela a cui hanno partecipato i maggiori teoreti della democrazia deliberativa, vuole riflettere sul momento democratico della società che si stava affacciando al nuovo millennio.
In molti dopo la caduta dell’Unione sovietica avevano iniziato a gioire del trionfo della democrazia liberale occidentale come unica forma definitiva di governo. Eppure questi inni vennero smorzati subito dall’avanzata dei nuovi stati autoritari, dei fondamentalisti islamici e sopratutto dai rigurgiti neofascisti in Francia, Italia o Stati uniti (proprio nel cuore dell’occidente).
Nonostante il mondo alle porte del nuovo millennio è un mondo dove le singole parti cominciano a rivendicare la propria identità con una pretesa di “unicità e perfezione”, iniziano a emergere anche nuove forme di “differenza” pronte a chiedere una nuova politica per il riconoscimento delle forme di identità collettiva.
Ciò è molto importante perché Seyla Benhabib è convinta che grazie alle esperienze dei nuovi movimenti sociali tra gli anni ‘70 e ‘80 è stato possibile intraprendere forme di politica dell’identità/differenza che hanno portato a importanti trasformazioni.
Le lotte per la ricchezza, la posizione politica e l'accesso che hanno caratterizzato la politica borghese e operaia per tutto il XIX secolo e la prima metà del XX secolo sono state sostituite da lotte per l'aborto e i diritti degli omosessuali, per l'ecologia e le conseguenze delle nuove tecnologie mediche, e dalla politica dell'orgoglio razziale, linguistico ed etnico.
Per Benhabib questi nuovi gruppi di attori politici, al posto dei partiti, hanno portato alla luce delle questioni importanti e ci sono riusciti perché le identità si nutrono delle differenze e dell’alterità. Solo attraverso il confronto riusciamo a stabilire le particolarità di una persona o di un gruppo e solamente grazie alle differenze è possibile parlare di dialogo. Per questo infatti la negoziazione dell'identità/differenza è il problema politico che le democrazie devono affrontare su scala globale.
In “Democracy and difference” gli autori e le autrici condividono l’idea per cui la democrazia, almeno al suo stato attuale, è troppo semplice per le società complesse e troppo complessa per quelle semplici. Per questo la teoria della democrazia deliberativa, come concepita da Habermas, parte dall’immagine di una società decentrata. Il sistema politico non è considerato né il vertice, né il centro, né tantomeno il modello formativo della società in generale, ma piuttosto un ulteriore sistema d'azione.
Seyla Benhabib difende anche lei il modello di una sfera pubblica decentrata ma rifiuta le nette distinzioni di Habermas sui discorsi etici, politici e morali. Benhabib ritiene che la versione della democrazia deliberativa proposta da Habermas separa troppo nettamente i processi politici dalle forme culturali di comunicazione.
Secondo Seyla Benhabib la democrazia può essere compresa come un modello per organizzare l'esercizio collettivo e pubblico del potere nelle principali istituzioni di una società sulla base del principio che le decisioni che incidono sul benessere di una collettività possono essere considerate il risultato di una procedura di deliberazione libera e ragionata tra individui considerati moralmente e politicamente uguali.
Benhabib privilegia quindi una concezione della democrazia basata sul metodo deliberativo, la condizione necessaria affinché ciò si avveri è che le istituzioni siano organizzate in modo tale da considerare l’interesse comune di tutti e quindi che la democrazia stessa sia il risultato di processi di deliberazione collettiva tra individui liberi e uguali.
L'idea di base di questo modello deliberativo è che le norme (cioè le regole generali di azione e gli accordi istituzionali) che possono essere considerate valide (cioè moralmente vincolanti) devono essere accettate da tutti gli interessati dalle conseguenze di queste stesse norme e che l’accettazione di queste conseguenze debba essere il risultato di un processo deliberativo in cui:
la partecipazione al processo deliberativo è regolata dalle norme di uguaglianza e simmetria (tutti hanno le stesse possibilità di prendere la parola, di porre domande, di interrogare e di aprire il dibattito);
tutti hanno il diritto di mettere in discussione gli argomenti di conversazione assegnati;
tutti hanno il diritto di avviare argomentazioni riflessive sulle regole stesse della procedura discorsiva e sul modo in cui esse sono applicate o attuate.
Seyla Benhabib nota che i processi deliberativi sono anche processi che trasmettono informazioni perchè 1) nessun individuo può anticipare e prevedere tutta la varietà di prospettive attraverso cui le questioni etiche e politiche potrebbero essere percepite da individui diversi e 2) nessun individuo può possedere tutte le informazioni ritenute rilevanti per una determinata decisione che riguarda tutti. D’altronde il capitalismo si basa esso stesso su una finzione metodologica che vede un individuo come un insieme ordinato di preferenze coerenti (talvolta in grado di avere tutte le informazioni di cui necessità per decidere).
Ed è qui che Seyla Benhabib individua una delle questioni per capire la complessità delle moderne democrazia: sulle questioni sociali e politiche nella maggior parte dei casi gli individui hanno opinioni e desideri e non un insieme ordinato di preferenze, quest’ultimo implicherebbe che essi siano informati in anticipo anche sulle conseguenze e sui meriti relativi di ciascuna delle loro scelte.
La democrazia deliberativa e il processo basato sui suoi principi potrebbe produrre questo risultato sperato da Benhabib portando l’individuo a una riflessione critica e approfondita sulle opinioni e sui punti di vista.
Ma non è tutto oro quello che luccica e questo vale anche per la democrazia deliberativa. Seyla Benhabib nota che i modelli di democrazia deliberativa sono spesso soggetti alla critica che non proteggono sufficientemente i diritti e le libertà fondamentali degli individui per due motivi:
nella misura la democrazia deliberativa attribuisce un alto valore al consenso o all'unanimità sulle questioni pubbliche, si potrebbe sospettare che tale unanimità possa essere raggiunta solo a costo di mettere a tacere il dissenso e limitare i punti di vista delle minoranze
quale tutela offre la democrazia deliberativa contro la dittatura della maggioranza che impone le proprie scelte e norme sulla minoranza? Insomma Squid Game ci ha insegnato molto negli ultimi anni su come le decisioni possono essere prese in modo molto sbagliato
Benhabib ritiene legittime queste obiezioni ma allo stesso tempo condivide l’idea kantiana per cui il rispetto morale per la personalità autonoma sia una norma fondamentale della moralità e della democrazia, per questo la democrazia deliberativa presuppone una teoria discorsiva dell'etica che gli fornisca i principi morali più generali su cui basare le rivendicazioni dei diritti.
In altre parole, nella misura in cui una teoria discorsiva dell'etica considera i partecipanti come esseri uguali e liberi, ugualmente titolari del diritto di partecipare ai discorsi che determinano le norme che influenzano la loro vita, la teoria della democrazia deliberativa parte da una visione delle persone come esseri titolari di determinati “diritti morali”. Il problema però è che questo va reso nella pratica per non incorrere nelle solite critiche di astrazione!
Proprio su questi punti si innesta la critica femminista alla democrazia deliberativa di autrici come Iris Young, la quale ritiene che la maggior parte delle teorie offrono una concezione troppo ristretta del processo democratico perché continuano a privilegiare un ideale di “un bene comune” in cui i partecipanti alla discussione dovrebbero tutti lasciarsi alle spalle le loro esperienze e i loro interessi particolari”.
Insomma sembra irrealistico che ci spogliamo di tutto ciò che ci caratterizza nel dialogare e contrattare delle cose che possono avere effetti su di noi e la nostra vita quotidiana. Per questo Young sostiene l’idea per cui gli individui dovrebbero prestare attenzione alle differenze di classe, genere, razza, religione e così via. Ogni posizione sociale ha una prospettiva parziale sul pubblico che non abbandona ma attraverso il processo dialogico i partecipanti trascendono e trasformano le loro conoscenze iniziali. Ma siamo tutti nelle stesse condizioni di poterlo fare?
La democrazia deliberativa nel pensiero di Amartya Sen
Amartya Sen, economista e filosofo nato nello stato indiano del Bengala Occidentale, non ha scritto un'opera sistematica sulla democrazia deliberativa nel senso stretto che troviamo in Habermas, Rawls, Elster o Benhabib ma ci dà un interessante spunto di riflessione per dare una risposta all’ultima domanda in sospeso.
Sen è famoso per aver teorizzato l’approccio delle capabilty, per cui il concetto di libertà è fondamentale. Sen ritiene che l’individuo prima deve soddisfare i bisogni fondamentali e poi deve essere libero di realizzare le soggettive potenzialità.
Di conseguenza il suo benessere è inteso attraverso i funzionamenti e le capacità:
con funzionamenti si intendono gli stati di essere e di fare, ovvero il ventaglio di opportunità di una persona come quello di essere ben nutrito o di essere libero
per capacità si intende la “capacità di funzionare”, ovvero l’effettivo accesso ai funzionamenti attraverso la possibilità e la libertà di scelta
Accanto a ciò, secondo Sen la democrazia è un processo di confronto tra punti di vista diversi, che si fonda sull’apertura al disaccordo e sulla possibilità di contestare pubblicamente ciò che viene considerato giusto o ingiusto. La giustizia non si impone da un modello ideale astratto, ma si costruisce attraverso il confronto situato tra soggetti con visioni del mondo, valori e capacità differenti. Per poter partecipare però tutti devono avere concretamente la capacità di portare il proprio punto di vista e avere la pretesa di essere ascoltati.
Sen sembra proporre una giustizia deliberativa orientata alla riduzione delle ingiustizie concrete. Questo comporta una democrazia deliberativa radicata nella realtà sociale, capace di confrontarsi con le disuguaglianze strutturali e con i limiti di accesso alla partecipazione
In questo caso, il capability approach definisce l’inclusione non solo come presenza formale ma come capacità reale di partecipare al processo deliberativo in modo significativo. Questo implica abbattere barriere materiali e cognitive; riconoscere i diversi modi di esprimersi e ragionare; offrire condizioni che rendano possibile esercitare l’“agency” democratica e quindi partecipare effettivamente al dialogo che presuppone la possibilità di potersi esprimere e la pretesa di essere ascoltato.
Quali sono i punti di forza e di debolezza della democrazia deliberativa?
Dalla rapida rassegna che abbiamo fatto è possibile sinteticamente individuare alcuni di quelli che possono essere i punti di forza o di debolezza della democrazia deliberativa.
Tra i punti di forze della democrazia deliberativa possiamo dire che:
La deliberazione è una “scuola di democrazia” che migliora competenze, consapevolezza e agency politica
Le decisioni sono più informate, ponderate, discusse collettivamente (migliora quindi la qualità delle decisioni)
Le scelte derivano da dialogo tra cittadini e cittadine, non da imposizioni top-down, permettendo la co-costruzione del bene comune
Il coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini rafforza la legittimità democratica
Si creano degli spazi democratici dove i conflitti vengono trasformati in confronto costruttivo
Vengono valorizzati i saperi esperienziali oltre a quelli tecnici
Il sorteggio stratificato promuove rappresentanza sociale ampia
Il processo, anche se spesso non vincolante, ha valore trasformativo a livello politico, sociale e culturale
Invece tra i punti di debolezza della democrazia deliberativa, che mi piace chiamare aree di miglioramento, possiamo dire che:
Rischiano di perdurare le asimmetrie di potere, le disuguaglianze preesistenti (culturali, linguistiche, cognitive) influenzano la partecipazione
Gruppi in condizione di marginalità o vulnerabilità possono restare fuori dal processo
Ci si potrebbe trovare davanti a una debole restituzione del potere decisionale a chi partecipa
Potrebbero esserci pochi strumenti per gestire il dissenso e accoglierlo
Le condizioni di accesso all’informazione non sono sempre garantite
Non c’è un vero accordo su cosa sia il “bene comune” e non c’è alcuna discussione approfondita su cosa significhi portando a un rischio di manipolazione retorica
Il sorteggio non basta a garantire vera inclusione
Mancano meccanismi strutturati per tradurre le raccomandazioni in policy
Questo ci tengo a specificarlo, preferisco parlare di aree di miglioramento perché un conto è la teoria e un conto è la pratica. Dopo questa ricchezza teorica che ha aiutato a delineare cosa è la democrazia deliberativa e che continua a studiare i possibili rischi, attualmente sono in corso delle sperimentazioni che vogliono tradurre i principi in pratica ispirandosi ai vari metodi della democrazia deliberativa (come ad esempio le assemblee dei cittadini, European Awareness Scenario Workshop, Consensus Conferences o le giurie dei cittadini). Per questo osservare e valutare le pratiche di democrazia deliberativa è fondamentale per coglierne le particolarità e le esperienze italiane recenti mostrano che le potenzialità esistono (alcune hanno anche utilizzato i Futures Studies!).
La democrazia deliberativa in Italia
Dal 2020 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha iniziato a parlare dell’ondata deliberativa, segno di una crescente diffusione delle pratiche di democrazia deliberativa.
I movimenti irregolari di questa onda ha toccato a più riprese le coste italiane e a partire dal 2006 si sono viste le prime pratiche di democrazia deliberativa in Italia. Il primo caso è quello della Regione Lazio dove nell'ambito del progetto “Economia Partecipata” l'Assessorato al Bilancio e alla Partecipazione ha promosso un Sondaggio deliberativo con James Fishkin sui temi della finanza etica e sugli investimenti, e sulla sanità regionali.
A partire da quella prima esperienza di democrazia deliberativa in Italia, tra il 2010 e il 2013 si sono svolte 8 pratiche di “Citizens Jury” (giuria dei cittadini) e 1 Consensus Conferences promosse in Toscana grazie alla legge regionale sulla partecipazione. La Consensus Conferences si è svolta a Castel Franco di Sotto (2011) mentre le “Citizens Jury” si sono tenute a Montale (2010), Marina di Carrara (2010), Buonconvento (2013), Lunigiana (2013), Scandicci (2013), Foiano delle Chiane (2011), Volterra (2013) e Carrara (2013).
Recentemente la democrazia deliberativa in Italia sta vivendo una nuova fase di vitalità attraverso la diffusione crescente diffusione di pratiche di assemblee deliberative (conosciute anche come assemblee dei cittadini), grazie alle azioni di mobilitazione e/o studio portate avanti da realtà della società civile o movimenti di attivisti come Extincion Rebellion Italia, ActionAid Italia, Osservatorio Italiano delle assemblee cittadine o Politici per Caso.
In particolare il fenomeno delle assemblee deliberative in Italia, escluse le esperienze promosse dal basso di Bulzi (tra le prime nel nostro paese) e dell’assemblea dei cittadini sulla genitorialità sociale, hanno visto l’istituzione di vere e proprie assemblee o percorsi sperimentali che hanno affrontato il tema della crisi climatica a Milano, Bologna, Firenze, Trento, Bolzano e Parma. Personalmente ho avuto la fortuna di far parte di un team di monitoraggio e valutazione per conto di ActionAid Italia e di osservare dal vivo l’Assemblea cittadina per il clima di Bologna e l’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima di Milano.
Perchè promuovere la democrazia deliberativa?
Come ogni cosa la risposta non è semplice e la democrazia deliberativa porta con sè numerosi metodi e pratiche che andrebbero valutate in base al contesto in cui si vogliono promuovere. Ciononostate ci troviamo davanti a tre dati di fatto:
la crisi climatica è la sfida più grande che le nostre democrazia abbiano mai visto in quanto stimolano a ripensare i nostri meccanismi di governo, spesso orientati sul breve periodo, per renderli capaci di riflettere anche sugli impatti per le generazioni future
in Italia, cosi come in tutte le democrazie del mondo, si assiste a una crisi di legittimazione della rappresentanza e a una costante devitalizzazione della forma di governo democratica perchè la cittadinanza si sente sempre meno protagonista della scelta pubblica e si sta allontanando dalla politica
partecipare alla decisione pubblica in materia di ambiente e clima è un nostro diritto, sancito da numerose atti internazionali, europei, fino alla nostra costituzione e che è stato rafforzato dal parere consultivo della Corte Internazionale di giustizia e dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera
Promuovere la democrazia deliberativa significa voler rimettere al centro tutte e tutti noi nella sfida della crisi climatica e tornare realmente a “fare politica” invece che assistervi solamente quando occorre votare.
Anche per questo nello studio dei processi deliberativi la domanda che solitamente ci si pone è quanto potere viene effettivamente restituito alle persone che partecipano. Di conseguenza è fondamentale tenere conto dei limiti che queste esperienze potrebbero trovarsi ad affrontare.
Al di là di ciò la democrazia deliberativa, per cui la piena legittimità della scelta pubblica si basa sulla discussione approfondita e informata tra tutti gli stakeholder toccati dall’oggetto della discussione, è una innovazione democratica capace di rispondere alla crisi di legittimazione della rappresentanza e di rivitalizzare la forma di governo democratica (per questo nel libro bianco degli Stati generale per l’azione per il clima trovi la proposta Co-costruzione delle politiche climatiche attraverso la democrazia deliberativa).
Infine la democrazia deliberativa si fonda sul principio che ogni persona debba avere la possibilità di contribuire alle scelte pubbliche, ed è proprio qui che è la sfida.
Più persone provenienti dai più diversi background, esperienze o stili di vita partecipano e più le scelte prese attraverso i metodi della democrazia deliberativa saranno in grado di creare politiche pubbliche aderenti ai territori e alle comunità.
Nella pratica, tuttavia, questo principio è spesso disatteso e anche nei contesti deliberativi si possono riprodurre dinamiche di esclusione o disuguaglianze che penalizzano coloro che hanno meno risorse od opportunità.
In altre parole, per salvarci dalla crisi climatica le nostre democrazie devono smettere di essere una cena per pochi. Purtroppo nella società della crisi climatica abbiamo smesso di parlarci, di confrontarci e trovare le soluzioni che non lascino davvero nessuno indietro. Dobbiamo tornare a stare insieme e affrontare il dilemma del porcospino perché nessuno si salva da solo nella crisi climatica.
E tu, cosa ne pensi? Hai mai sentito parlare di democrazia deliberativa o ti è capitato di partecipare a una di queste pratiche? Oppure hai domande a cui posso rispondere?
Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica